Performing Pac. Intervista a Susanne Franco
Parola alla studiosa e docente di storia della danza all’Università Ca’ Foscari di Venezia Susanne Franco, protagonista di uno dei talk organizzati dal PAC di Milano nell’ambito della tre giorni dedicata alle arti performative.

Un appuntamento cruciale per gli studi sulla performatività, le tre giornate al PAC di Milano: tre talk, tre performance (Dora Garcia, Paulien Oltheten, Cristina Kristal Rizzo e Annamaria Ajmone), due flashback (Vito Acconci e Gina Pane), dodici video d’archivio.
Apre ‒ il primo marzo ‒ il ciclo di conferenze Susanne Franco, studiosa, docente di storia della danza all’Università Ca’ Foscari di Venezia. A seguire, il 2 marzo, Lois Keidan, tra i fondatori della Live Art Development Agency di Londra e a chiudere, il 3 marzo, André Lepecki, direttore del dipartimento di Performance Studies della New York University.
Ne approfittiamo per indagare il tema della relazione tra le arti performative (danza e performance) e le arti visive in una discussione con Susanne Franco.
Sempre più musei si aprono alle performing art, non solo alla performance ma anche alla danza… e il PAC ne è un grande esempio in Italia.
Sicuramente la presenza della danza nei musei e nelle gallerie d’arte è uno dei fenomeni più interessanti e diffusi del momento. Molti musei si stanno attrezzando con curatori e spazi appositamente dedicati.
Come influisce questo sulla danza, sulla performance art e sull’arte visiva?
Per i danzatori e i coreografi spesso queste sperimentazioni rappresentano un modo per fare i conti con la propria storia, o meglio con le narrazioni tradizionali della storia della danza, nella quale si intrecciano i ricordi individuali degli artisti a quelli collettivi della comunità di riferimento. In questo modo contribuiscono a preservare e mantenere vivo un patrimonio immateriale e ad attivare nuove forme di trasmissione di un’eredità, sia essa una tradizione coreutica, una tecnica o un repertorio. Inoltre, affiancando il processo di rimemorazione a quello della documentazione, e dialogando con le opere d’arte esposte, questi artisti mettono in scena la storia tramite la memoria. E se nei musei e nelle gallerie d’arte gli artisti hanno la possibilità di trasmettere una storia e una cultura a chi non la conosce, d’altro canto, proprio la danza si sta rivelando un veicolo efficace per far fruire l’arte visiva ai visitatori in modo inaspettato. Si tratta di un grande potenziale di cui tenere conto per lo sviluppo di nuove strategie museali.
È vero che esiste una tendenza “performativa” nella danza, ma anche una tendenza “coreografica” nell’arte visiva? Penso ad artisti come Philippe Parreno, e alla sua mostra Anywhere anywhere out of the world (2013-2014) o a Pierre Huyghe, con la sua personale al Centre Pompidou del 2013.
In linea generale trovo le suddivisioni per generi più fuorvianti che illuminanti e nemmeno la distinzione tra performance art e danza ha più molto senso di esistere. Ciascun genere ha la sua storia e alcune caratteristiche più o meno ricorrenti di cui tenere conto, e tuttavia penso che sarebbe più produttivo e sensato parlare semplicemente di spettacolo e arte contemporanea.

Grethell Rasúa, Decreto mis ideales. Performance at PAC, Milano 2016. Photo Annamaria La Mastra
Sono molti gli interventi di coreografi nei musei. Il lavoro di Virgilio Sieni qui a Milano alla Fondazione Prada, o la mostra Work / Travail / Arbeid di Anne Teresa de Keersmaeker al Centre Pompidou o Performing Arts del più giovane Noé Soulier (spettacolo in cui il coreografo mette in scena il processo di installazione di una mostra utilizzando le opere della collezione del museo che lo ospita). Cosa può dirci, dal suo punto di vista di studiosa esperta di danza oltre che docente universitaria?
Le diciture che portano allestimenti recenti di opere coreografiche dentro musei, gallerie e in teatri e definite come “mostra coreografica” o “installazione coreografica” sono solo il primo sintomo delle contaminazioni in atto tra arti performative e arti visive, ma è cosa ci raccontano gli artisti di loro, dei linguaggi che utilizzano, della loro storia e del modo in cui vedono il mondo in cui siamo immersi che deve attirare la nostra attenzione.
Per la mostra Il tempo del Postino (2009), Hans Ulrich Obrist chiede agli artisti visivi coinvolti di lavorare sul tempo piuttosto che sullo spazio. Con Philippe Parreno avrebbero voluto allestire questa mostra collettiva in un teatro…
Philippe Parreno ci aiuta a precisare un punto importante: l’andirivieni dalle arti visive alla danza e alla performance arte è di lunga durata così come le riflessioni sugli aspetti temporali e spaziali di questi linguaggi artistici. L’impianto drammaturgico della sua mostra Hypothesis allestita all’HangarBicocca era concepito come uno spazio in cui una serie di eventi accadevano in successione. Una tappa di questo percorso era costituita dalla presenza dei parallelepipedi trasparenti realizzati da Jasper Johns per uno spettacolo di Merce Cunningham per omaggiare Marcel Duchamp, riproducendovi sui lati Il Grande Vetro di Duchamp, che a sua volta è un’opera con un forte impianto coreografico e in cui il tempo è imprigionato nella struttura. Questa stratificazione di citazioni e di rimandi funziona come un concentrato di storia delle arti visive e della danza del XX secolo.
Parallelamente, quando coreografi e danzatori entrano in uno spazio museale sono invece chiamati a confrontarsi con la dimensione spaziale, che in un museo diventa una variabile capace di influire in modo notevole sulla partitura coreografica, rispetto a un palcoscenico teatrale. Credo che questo sia un nodo cruciale. Cosa ne pensa?
Oggi assistiamo a una sorta di seconda ondata di questo dialogo tra arti visive e performative, scandito dalle numerose incursioni della danza e della performance negli spazi museali. Il passaggio dal Black Box, ovvero dal modello più tradizionale di disposizione spazio-temporale dello spettacolo teatrale, al White Cube, la disposizione spaziale e temporale che si vuole neutra e per questo ottimale per esporre le opere d’arte, sta producendo, da un lato, uno slittamento delle convenzioni che regolano le due tipologie di istituzioni e, dall’altro, sta generando nuove soluzioni artistiche.
E per quanto riguarda l’esperienza dello spettatore, che ruolo gioca questa commistione?
A teatro lo spettatore arriva con delle precise aspettative (determinate dalle convenzioni che regolano il rapporto con la scena) e fruisce dello spettacolo da una precisa prospettiva e per un tempo che sono stati decisi per lui a priori da altri. Nel caso dell’esposizione museale, invece, l’esperienza si basa sul principio di autonomia del visitatore, che sceglie quando e quanto a lungo mettersi in relazione con un’opera. La presenza della performance e della danza negli spazi espostivi e museali porta, dunque, inevitabilmente a problematizzare la relazione tra visitatore e opere d’arte e a ripensare le aspettative del pubblico.
Ciò detto, penso che la dimensione temporale sia tanto importante quanto quella spaziale. Per esempio allestire uno spettacolo in un museo rende possibile mostrare vari lavori insieme e in un unico spazio o edificio, in modo che i visitatori possano sperimentarli simultaneamente o in sequenza.

Marina Abramovic, The Abramovic Method. Performance at PAC, Milano 2012. Photo Laura Ferrari
Ci fa un esempio?
Un caso emblematico è la mostra Rétrospective del coreografo francese Xavier Le Roy, inaugurata a Barcellona presso la Fundació Antoni Tàpies nel 2012 e successivamente allestita in altri musei e gallerie. All’invito della Fondazione a realizzare una retrospettiva del suo lavoro, Le Roy ha reagito chiedendosi come si potessero portare tutte le sue produzioni all’interno di una galleria d’arte. Nel corso dei tre mesi della durata della mostra, Le Roy ha pensato di trasporre una serie di assoli del passato, ponendo la danza in dialogo con le altre “arti del tempo” per avviare un’indagine auto-riflessiva dell’artista sul suo corpus coreografico. Ha selezionato tre tipi di lavori solitamente esposti nelle gallerie, ciascuno con la sua specifica “durata”, vale a dire fotografie, sculture o oggetti; opere video proiettati in loop; e installazioni che possono essere fruite secondo una durata variabile. Queste tre categorie hanno fornito la struttura delle azioni dei performer coinvolti in quella sala: uno eseguiva una sorta di fermo immagine ispirato agli scatti fotografici di una performance, un altro eseguiva un frammento di danza in loop, e il terzo si rivolgeva al pubblico spiegando l’opera di Le Roy e intrecciando una spiegazione dell’opera di Le Roy con un flusso autobiografico su come lui/lei l’avevano conosciuta e percepita. Le azioni cambiavano nel momento in cui entravano nuovi visitatori e questa regola consentiva di modificare i ruoli e le posizioni dei performer grazie a un sistema a staffetta circolare, che offriva un’esperienza fisica del montaggio concettuale e performativo delle temporalità del lavoro.
E se portassimo gli artisti visivi nei teatri?
Certo, se si iniziasse a sperimentare riflettendo su cosa succederebbe in un transito inverso degli artisti visivi dal White Cube al Black Box, il panorama si arricchirebbe ulteriormente e molte soluzioni artistiche stimolerebbero i nostri sensi e i nostri pensieri. Allo stesso modo, altre riflessioni teoriche troverebbero un nuovo terreno per essere verificate e approfondite.
Ereditare la storia, danzare la memoria è il titolo del suo intervento al PAC, che tema importante! Cosa spinge i coreografi a confrontarsi oggi con il tema della memoria?
La memoria, ovvero quell’insieme di pratiche culturali, individuali e collettive, discorsive e incorporate, che permette di conservare, salvaguardare e trasmettere immaginari e rappresentazioni del passato, è un tema che negli ultimi vent’anni è stato indagato da molte prospettive disciplinari oltre che dagli artisti. Questo fenomeno non è privo di legami con il desiderio di reagire alla temporalità imposta dai media, dalla tecnologia e dai nuovi sistemi di comunicazione che tendono alla simultaneità. Molti fattori hanno trasformato il nostro modo di ricordare e di rappresentare la memoria, segmentando o ristabilendo la continuità della trasmissione del passato, individuale e collettivo: le scoperte della psicologia cognitiva e della neurofisiologia sul funzionamento delle reti neuronali nell’atto di ricordare, ma anche la proliferazione di documentazione accessibile in rete che alla fine, spesso, disorienta. E ancora: la scomparsa degli ultimi testimoni dei grandi traumi e tragedie del secolo scorso, così come quella dei grandi protagonisti della danza e della performance art, i fenomeni migratori e diasporici, il postcolonialismo e la globalizzazione, e non da ultime le politiche della conservazione si mostrano sempre più orientate a ridefinire tutte le forme di patrimonio come immateriali in quanto il vero oggetto da preservare sono i valori e i significati rappresentati dai luoghi e dalle pratiche culturali e in misura minore i resti materiali.

Carlos Martiel, Trofeo. Performance at PAC, Milano 2016. Photo Annamaria La Mastra
E l’interesse mostrato invece dagli studiosi rispetto a questo stesso tema?
Dal canto loro, gli studiosi sentono sempre più forte l’esigenza di includere nelle proprie ricerche la memoria, intesa come forma di sapere e come strumento per interrogare la storia, per guardare in modo nuovo a quanto non è entrato in repertorio o non è stato tramandato per via istituzionale e, non essendo ritenuto canonico, è caduto nell’oblio. Nell’insieme, queste nuove ricerche artistiche e storiche stanno rivelando una dimensione ben più complessa e problematica del passato della danza e della performance art, dei loro protagonisti e degli spettatori.
Penso a (untitled) (2000), l’ultima coreografia creata da Tino Sehgal prima di lasciare la danza per le arti visive: “un assolo maschile che ripercorre la storia della danza del Novecento”, ma tanti sarebbero gli esempi. Cosa induce i coreografi a occuparsi sempre più della storia della danza? In quale momento le pratiche coreografiche entrano a far parte della “storia”?
La storiografia della danza di stampo tradizionale e positivista si è basata su una logica cronologica e una presunta linearità dei fenomeni che selezionava e registrava, costruendo delle genealogie precise di maestri e allievi, che altri sguardi su altre tipologie di fonti hanno radicalmente messo in discussione. In questa fase cruciale per il ripensamento dei fondamenti e delle finalità della storia della danza, il contributo degli artisti si sta rivelando prezioso. In scena, per stabilire un rapporto col passato, alcuni coreografi ricorrono alla citazione di uno spettacolo e ne omaggiano il creatore e/o l’interprete, evocandone movimenti, atteggiamenti e pensieri; altri incastonano sequenze coreografiche provenienti da opere altrui o elementi di tecniche coreutiche in lavori che poi presentano al pubblico come nuovi; altri ancora espongono temi e argomenti già affrontati in opere precedenti con cui stabiliscono un dialogo a distanza, spesso mescolando i loro ricordi individuali o quelli dei danzatori. Molti di loro, infine, stabiliscono un legame diretto con la storia della danza e della performance art a cui sentono di appartenere o, al contrario, da cui desiderano emanciparsi perché, così come è raccontata nei manuali e tramandata a voce dai “maestri”, risulta loro estranea. Gli slittamenti, gli oblii, le forme di resistenza all’insegnamento dei “maestri” non sono più considerati delle eccezioni.
Restando sul tema della memoria. Il tema dell’“archivio”è molto presente oggi nelle discussioni degli addetti ai lavori delle diverse discipline artistiche, sia in termini teorici che pratici. Le compagnie di Merce Cunningham, Pina Bausch, Trisha Brown continuano a portare avanti il lavoro dei coreografi che le hanno fondate (un repertorio che può essere definito “vivo”?), ma cosa mantiene viva la memoria del lavoro di quei coreografi che erano slegati da una compagnia come Mats Ek e tanti altri? La documentazione? Il re-enactment tanto in voga nella performance art? O saranno vittime dell’oblio?
Il tema dell’archivio è centrale anche nella danza, che ha portato il peso della retorica dell’effimero. La cultura dominante ha favorito la trasmissione dell’esperienza in forme scritte, mentre la danza, che si basa sul corpo e non fa riferimento a un testo e talvolta nemmeno a un linguaggio codificato e trasmissibile attraverso una o più scritture, è stata posta dalla cultura dominante nel regno della immaterialità e dunque della perdita. Ma l’immaterialità delle opere di danza è più un segno della nostra incapacità di coglierne le tracce, che un tratto fondante della sua identità. La danza lascia tracce, seppure difficilmente decodificabili secondo i parametri che feticizzano i resti materiali della storia. La ricerca, di conseguenza, richiede strumenti metodologici e orizzonti teorici adeguati a identificarle e a esaminarle. Tenere presente la complessa dimensione della memoria incorporata nella danza è utile, per esempio, a mettere in discussione la presunta unicità di alcune modalità di trasmissione da maestro ad allievo in virtù della loro veste istituzionale.

Susana Pilar Delahante Matienzo, El tanque. Performance at PAC, Milano 2016. Photo Nico Covre
Quale “archivio” è possibile per lo spettacolo dal vivo?
Per lo studio della danza, ma anche della performance art, l’archivio va ripensato in termini di trasmissione corpo a corpo, di archivio corporeo e di processi di incorporazione. Direi anche di più, la performance art e la danza sono una riserva di memoria incorporata e al tempo stesso un modo di ricordare, preservando e insieme trasformando continuamente il senso di quanto è trasmesso. In altre parole, se i corpi sono luoghi della memoria, i corpi in movimento sono forme di archiviazione e dunque di trasmissione di un sapere. Mentre vanno delineandosi via via i contorni di un’era del post-effimero, l’aspetto più interessante di questa svolta epocale che sta segnando la danza e la performance art risiede nel fatto che sono gli artisti a stimolare gli studiosi a rimettersi in discussione e a ripensare profondamente la storia di queste pratiche artistiche.
Di cosa parlerà al PAC ?
Al PAC parleremo proprio delle politiche di trasmissione del repertorio messe in campo dalle compagnie di Merce Cunningham (che è stata chiusa a due anni dalla morte del suo corografo unico e per sua espressa volontà) e di Pina Bausch, il Tanztheater Wuppertal, che invece continua sotto la direzione Adolphe Binder che, a differenza dei primi tre direttori succeduti alla morte di Bausch, non ha alcun rapporto diretto con la compagnia. Ma la trasmissione del repertorio in entrambi i casi è mediata e regolata da Fondazioni e Trust, che tutelano gli archivi, i diritti d’autore e il rispetto delle clausole stipulate dagli artisti prima di morire. Sono repertori vivi, ma in modi diversi. I coreografi che non hanno una compagnia hanno molte altre possibilità di trasmettere il loro patrimonio materiale e immateriale e certamente le numerose declinazioni del re-enactment che vediamo proliferare sulle scene internazionali sono un costante stimolo a pensare nuove strategie di resistenza all’oblio. Ma la danza è un sapere che spesso si inabissa come un fiume carsico, riapparendo in un altrove spazio-temporale difficile da prevedere. Dunque l’eredità di questi coreografi verrà traghettata da chi l’ha fatta propria danzandola e la passerà ad altri, più o meno consapevolmente e più o meno direttamente.
Al PAC parleremo di tutto questo ma anche del progetto Musée de la danse di Boris Charmatz, di lavori coreografici che partono dai ricordi del pubblico, di canone, repertorio, trasmissione e di memoria virale in rete per mostrare tutta la complessità e il fascino di questo tema.
Ritiene che la performance art, più delle altre arti, si sia fatta carico di un messaggio politico, come i tre interventi di questo convegno sembrano dimostrare? È ancora così? O la danza inizia oggi a occuparsi anche di temi prima più distanti?
La performance art e la danza, in modi e tempi diversi legati alle proprie specificità e alle proprie storie, sono sempre ideologiche e per questo provocano inevitabilmente degli effetti politici. Il modo in cui la performance art e la danza alterano e usano lo spazio pubblico attraverso la presenza e la circolazione di corpi è pieno di implicazioni politiche. La danza, arte corporea per eccellenza, che plasma il corpo e il suo modo di muoversi, non può che proporre modelli di soggettività e identità, aderendo a quelli normativi o ribellandosi. Più che nella performance art e nella danza, il politico è nel modo in cui la performance art e la danza occupano lo spazio (culturale). Ciò detto, è proprio la contaminazione tra la performance art e la danza che ci porta a riflettere sulle nuove modalità di creazione e di ricezione di un messaggio politico veicolato dall’arte e non da ultimo sul nostro ruolo di spettatori.
‒ Chiara Pirri
 1 / 14
1 / 14
 2 / 14
2 / 14
 3 / 14
3 / 14
 4 / 14
4 / 14
 5 / 14
5 / 14
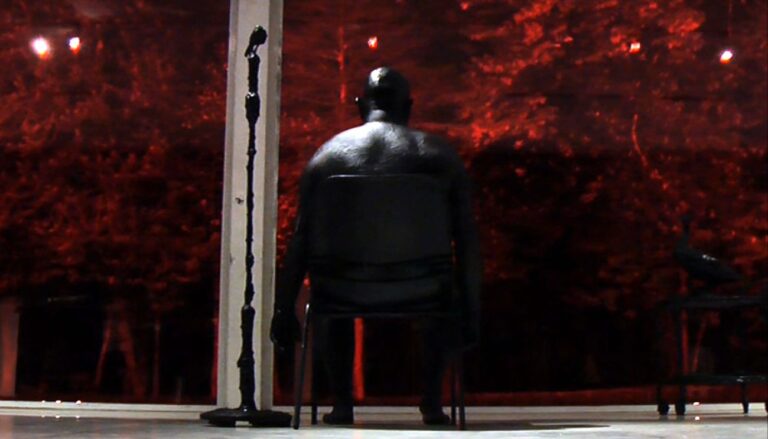 6 / 14
6 / 14
 7 / 14
7 / 14
 8 / 14
8 / 14
 9 / 14
9 / 14
 10 / 14
10 / 14
 11 / 14
11 / 14
 12 / 14
12 / 14
 13 / 14
13 / 14
 14 / 14
14 / 14
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati



















