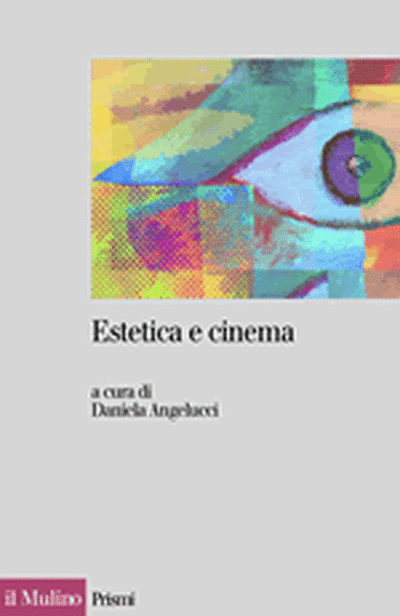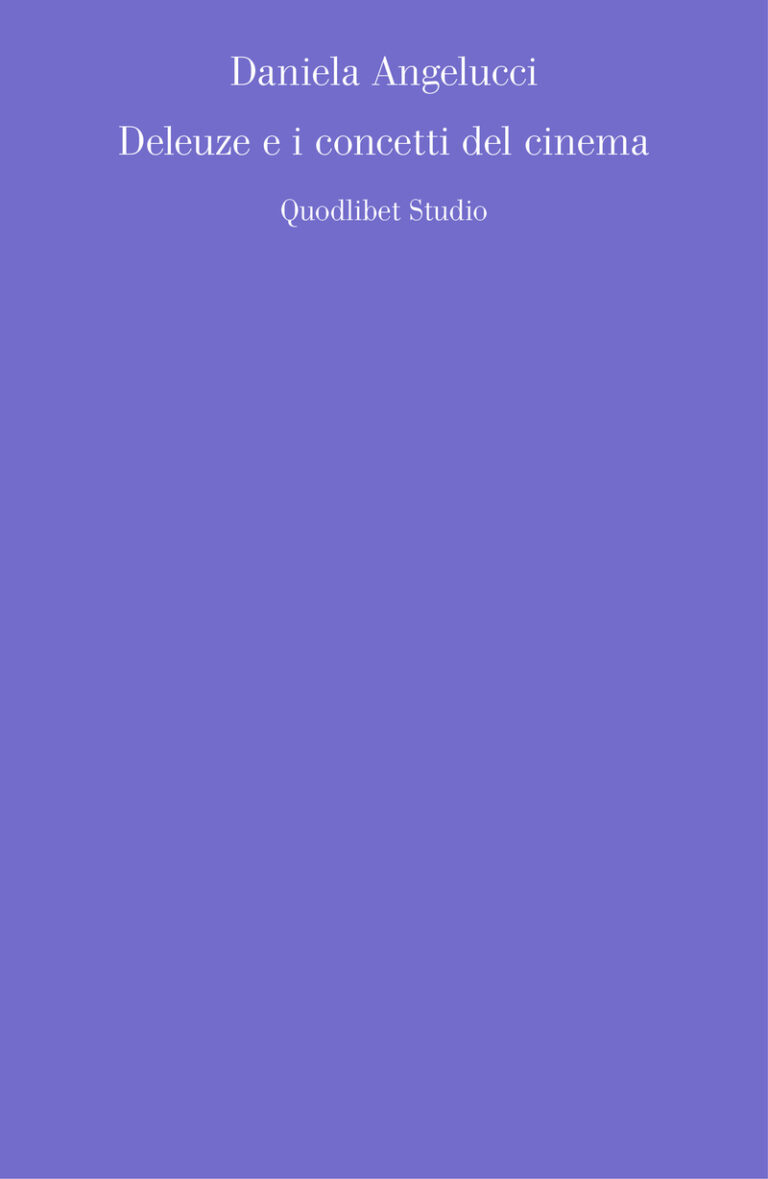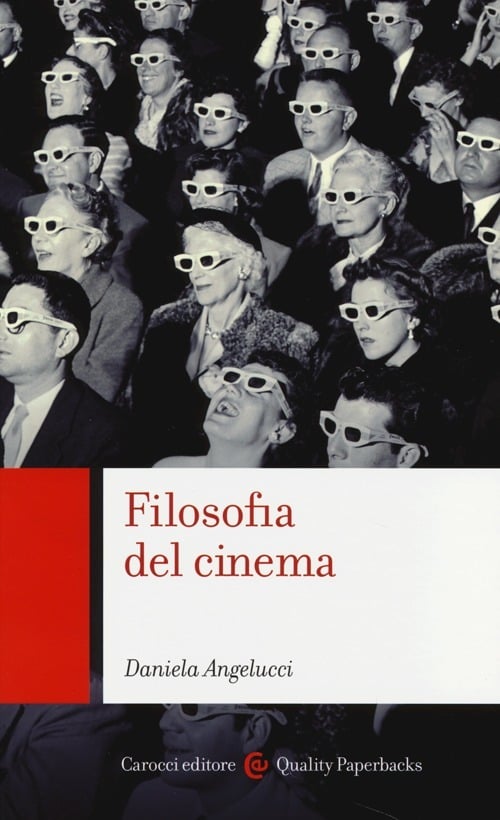Dialoghi di Estetica. Parola a Daniela Angelucci
Daniela Angelucci insegna Estetica presso l’Università Roma Tre, dal 2006 al 2010 ha insegnato Estetica e teoria del cinema all’Università della Calabria. Ha collaborato alla “Enciclopedia del cinema” pubblicata dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Tra i suoi libri “Filosofia del cinema” (Carocci, 2013), “Deleuze e i concetti del cinema” (Quodlibet, 2012). Ha curato “Estetica e cinema” (Il Mulino, 2009) e “Reinventare il reale. Jean Baudrillard (2007-2017)”, con E. Schirò ed E. De Conciliis, nr. speciale di “Lo sguardo”, 2017. Il rapporto tra filosofia e cinema, la sua natura artistica, i legami con la realtà e la vita sono i principali temi che abbiamo affrontato in questo dialogo.

Durante il secolo scorso, il discorso teorico sul cinema si è sviluppato su due assi: quello dei suoi autori, i registi, e quello di teorici, critici e intellettuali impegnati a coglierne le specificità e l’essenza. Rispetto a queste direzioni, che posizione ha la filosofia nella “macchina discorsiva” sul cinema?
La mia tesi è che il cinema, più delle altre arti, abbia subito una forte influenza da parte dei discorsi teorici, portati a riflettere sulla natura del nuovo mezzo proprio a causa della sua incerta natura artistica. La genesi tecnica del cinema, l’incertezza iniziale sui suoi obiettivi – ludici? scientifici? espressivi? – ha indotto gli intellettuali che avevano intuito le sue potenzialità artistiche a riflettere, scrivere, dibattere, alimentando il lavoro dei registi che naturalmente ha a sua volta alimentato la teoria. Dunque, sin dalle sue origini il cinema si è costituito in un intreccio di teoria e pratica, la “macchina discorsiva” (come la ha definita Christian Metz) ha improntato di sé il lavoro pratico, nonostante, anzi proprio a causa di, quello che ho chiamato il suo “peccato originale”: non essere nato nella notte dei tempi dal bisogno espressivo degli esseri umani, come la pittura per esempio, ma avere una natura ibrida, tecnica, industriale. Si tratta di uno di quei casi, interessanti per il lavoro filosofico, in cui un’apparente povertà si trasforma in una ricchezza. Esagerando un po’, vorrei dire che il cinema, con la sua artisticità ambigua, è sempre una tentazione per i filosofi.
Entriamo un po’ più nel dettaglio. Considerando anche le ricerche più recenti, come sono influenzati gli studi filosofici sul cinema dall’estetica?
Almeno dagli Anni Novanta il cinema è entrato nei dipartimenti di filosofia, all’Università. In ambito anglosassone si è diffusa, con cattedre, riviste e convegni così intitolati, la locuzione Philosophy of film, formula ormai codificata che rende l’idea della ampiezza della riflessione filosofica su questo tema. In questo insieme di teorie si possono individuare diverse prospettive: quella analitica, angloamericana, che porta avanti soprattutto una riflessione ontologica sui film, sulla loro natura e definizione, come anche sulla essenza delle emozioni (vere? finte?) degli spettatori; e quella continentale, più variegata e volta alle questioni estetiche in senso stretto. Dal mio punto di vista, quello di una prospettiva estetica, mi interessa lavorare sull’intero dispositivo dell’esperienza cinematografica: non solo i film, e i loro autori, ma anche la questione della spettatorialità, della visione, il rapporto con le immagini. A volte i filosofi utilizzano il cinema come un enorme serbatoio di contenuti, di esempi, di storie e personaggi, al fine di illustrare le proprie teorie, mettendo la narrazione al servizio delle loro tesi. Questa modalità è forse utile ai fini della didattica, ma non è certo una estetica del cinema, dato che spesso trascura proprio l’aspetto stilistico, e fa dei film degli strumenti invece che degli oggetti, e anche dei soggetti, di pensiero.
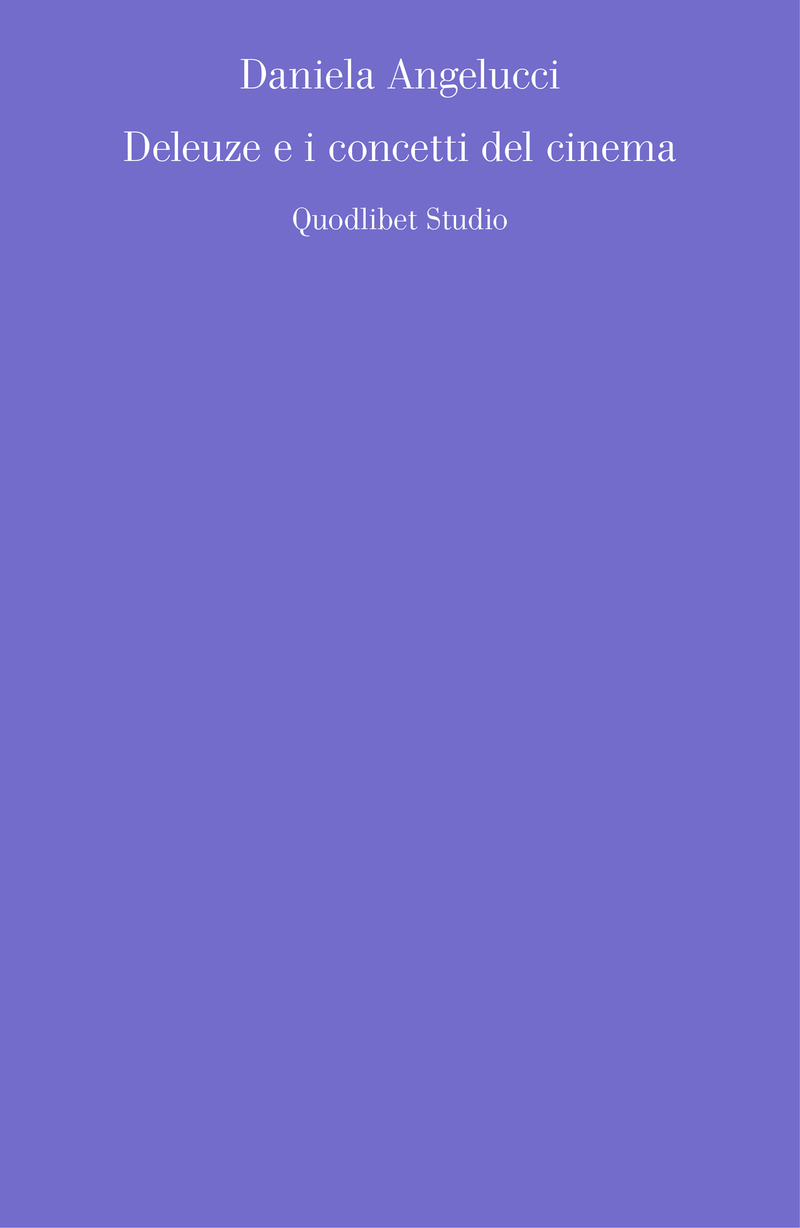
Daniela Angelucci, Deleuze e i concetti del cinema (Quodlibet 2012)
Insieme alla discussione sulle sue potenzialità tecnologiche, ai suoi esordi il discorso sul cinema era anche caratterizzato da un considerevole scetticismo verso la sua natura artistica. Come si configura oggi la riflessione sull’artisticità del cinema?
Ormai non c’è più bisogno, per fortuna, di difendere il cinema dall’accusa di non essere un’arte: da una parte, le potenzialità espressive del mezzo cinematografico vengono facilmente riconosciute, dall’altra non c’è più una distinzione così netta tra cinema d’autore e cinema di intrattenimento, come accadeva invece qualche decennio fa. Per fare un esempio, uno dei registi di cui in questi ultimi anni si è maggiormente resa evidente la cifra autoriale, Quentin Tarantino, fa film leggibili e godibili anche a livello spettacolare. Direi piuttosto che a essere fortemente cambiato è il concetto di “arte”: le pratiche artistiche si sono evolute e trasformate così tanto dalla fine dell’Ottocento a oggi – non a caso parliamo di arti e non di Arte – che l’aspetto popolare del cinema e la sua genesi tecnica non creano più alcun problema, né agli appassionati né agli esperti.
L’artisticità del cinema è determinata soprattutto dai suoi tratti metaforici, visivi, onirici. Tuttavia, come aveva osservato Pier Paolo Pasolini, considerare il suo potenziale immaginifico non vuol dire però disinteressarsi delle sue fondamenta concrete. Al contrario, significa riconoscere anche quel patrimonio comune appartenente alla dimensione umana e basato su regole proprie, che il regista potrà a suo tempo tradurre in immagini. Una sorta di base pre-poetica che rende possibile la poesia. Che cosa pensi di questa concezione del cinema?
La riflessione di Pasolini sul cinema è interessante in primo luogo per l’esito inaspettato rispetto alla posizione di partenza, che è quella interna al dibattito sulla semiologia. Mentre ci si chiedeva se il cinema possa considerarsi una lingua oppure se debba ritenersi un linguaggio, il regista affermò in modo radicale che esso corrisponde alla lingua naturale del mondo, fatta di segni visivi. Il motivo per cui le immagini cinematografiche riescono a comunicare con lo spettatore è insomma il fatto che esse si fondano su un patrimonio originario comune, cioè l’aspetto visivo del nostro mondo costituito dai gesti mimici. Secondo Pasolini è l’intera vita a farsi cinema vivente. Ciò che mi interessa di più in questa posizione è che il riconoscimento di questa base irrazionale e primitiva del cinema porta all’esaltazione delle sue qualità poetiche. Pasolini, con il suo stesso lavoro registico, ha proposto un cinema che aderisce anche affettivamente ai suoi personaggi, che recupera gli aspetti onirici, lasciati sotto traccia dalla strada più narrativa e prosaica presa dal cinema.
Se il cinema ci mostrasse il mondo e la realtà per quello che sono, probabilmente ci interesserebbe molto meno. Eppure, come emergeva nitidamente dal dibattito sviluppatosi intorno alla metà del Novecento – penso, per esempio, alla riflessione di Cesare Zavattini che insisteva sulla “fame di realtà” del cinema e sulla necessità di fare poesia proprio a partire dal reale – il cinema è anche immagine dell’ordinario prima che dello straordinario. Che relazione c’è tra cinema e realtà?
La questione del rapporto tra arte e realtà è millenaria: da una parte chi, come Platone, ha criticato le arti mimetiche in quanto soltanto copie della realtà, dunque lontane dalla verità; dall’altra chi, come i detrattori del cinema e della fotografia nel momento della loro nascita, ha visto nella fedeltà estrema dell’immagine al reale una impossibilità di trasfigurazione artistica. Ma la distinzione tra registi dell’immaginario e registi dell’immagine-fatto, pur sottolineando una questione fondamentale, contribuisce a nascondere quello che per me è l’essenziale: il fatto che, come la creazione di un mondo immaginario permette l’emersione di aspetti nascosti, così la vicinanza del cinema al reale è tanto più forte quanto più l’immagine restituita viene messa in forma attraverso i procedimenti propri del lavoro artistico. Mostrare, presentare la realtà, con la sua ambiguità e le sue improvvisazioni, non è qualcosa che può farsi attraverso una brutale registrazione del dato, ma prevede sempre un raffinato lavoro di stilizzazione. Anche un autore come André Bazin, teorico del realismo, afferma che ogni realismo in arte è in primo luogo un realismo estetico. Zavattini, che cercava l’adesione totale del cinema alla vita, è stato uno dei più grandi sceneggiatori del cinema italiano e, come affermò Bazin, la sceneggiatura di Ladri di biciclette è diabolica!
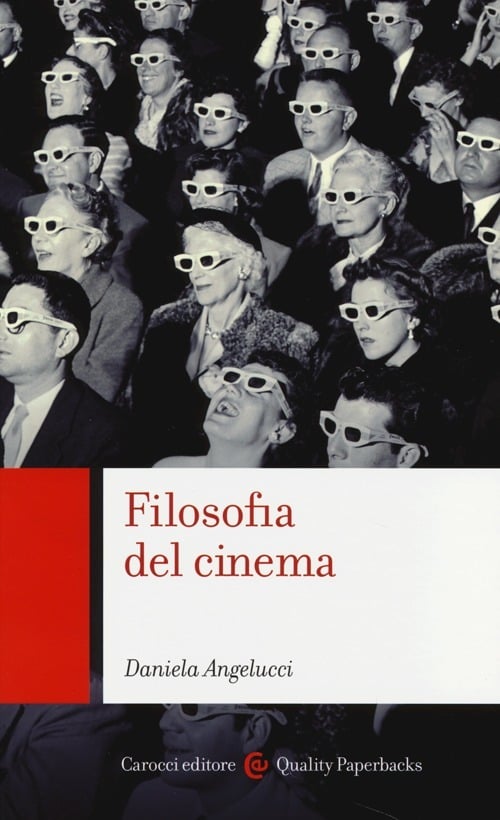
Daniela Angelucci, Filosofia del cinema (Carocci 2013)
Il pensiero di Henri Bergson è stato un riferimento importante per la filosofia del cinema novecentesca. La questione della durata ritorna infatti più volte nelle riflessioni di autori diversi – da Gilles Deleuze a Jean-Paul Sartre, a Zavattini. Verrebbe da dire che, forse, a essere centrale sia un pensiero sul cinema guidato anzitutto dalla riflessione sulla sua continua evoluzione. Qual è la tua idea in proposito?
Il riferimento a Bergson riguarda in primo luogo il tipo di realtà che nel cinema viene mostrata: la durata indica proprio il flusso vitale che il cinema è in grado di farci vedere, un fluire caratterizzato da una continua trasformazione qualitativa, pieno di imprevisti e novità. Gli autori che citi traggono dalla riflessione bergsoniana sul tempo proprio questo carattere di creazione continua, per il quale il passare del tempo non è mai una somma di istanti uguali e misurabili.
La tua osservazione sulla evoluzione del cinema è molto sottile, e forse questo modo di intendere il reale riguarda anche la riflessione sul mezzo cinematografico stesso, che dalle sue origini a oggi è molto cambiato: è cambiata la tecnologia, sono cambiati i luoghi e i modi della fruizione. Il mio riferimento personale quando penso all’esperienza cinematografica è ancora quello della sala, ma non è così oggi per molte delle mie studentesse e dei miei studenti, pure seriamente appassionati di cinema. Da una parte, da teorica, apprezzo la possibilità di poter osservare da vicino cambiamenti importanti, dall’altra devo dire che rimango convinta di una certa continuità delle motivazioni espressive e spettatoriali. Per questo motivo, a volte sono nostalgica, ma mai molto spaventata dai cambiamenti.
Deleuze ha dedicato al cinema ben due libri: L’immagine-movimento (1983) e L’immagine-tempo (1985). In essi il cinema è concepito come un’attività creatrice che può essere considerata analoga al pensiero filosofico: quest’ultimo è dedito alla produzione di concetti, il cinema crea immagini. Se dovessi ricapitolare la sua filosofia del cinema in tre concetti, quali sceglieresti?
Il primo punto importante è proprio questa vicinanza tra cinema e filosofia da te citata: dire che cinema e filosofia sono due pratiche inventive è decisivo soprattutto per la filosofia, che nella risonanza con il cinema si trasforma e non è più riflessione a posteriori, ma come capacità di inventare nuovi concetti, nuove parole. Il secondo concetto, inventato da Deleuze nel senso che ho appena detto, è quello di “immagine-tempo”: si tratta di quel tipo di immagine, predominante in un certo cinema (che per Deleuze si sviluppa dal neorealismo in poi), in grado di arrestare il fluire automatico della trama per esporsi alla visione nella sua pregnanza estetica. La “temporalità in persona” che il cinema è in grado di rendere visibile – non un tempo che passa attraverso il procedere dell’azione, ma un divenire in sé – è una sorta di essere, di pensiero puro, che può apparire nel momento in cui l’immagine emerge dallo schermo con forza, quasi scissa dalla narrazione. Si tratta in fondo di quello che in altri testi Deleuze chiama vita, o “immanenza”, ovvero il terzo concetto che vorrei evidenziare. Nel corso di tutta l’opera, fino all’ultimo testo Immanenza: una vita…, Deleuze ricerca la possibilità di un’apprensione immediata delle forze vitali pure, in divenire, della vita impersonale, al di là di ogni rappresentazione che possa bloccare il suo flusso. Il cinema colpisce Deleuze proprio per la sua “attitudine inaspettata” a mostrare il pensiero, la vita immanente, attraverso il divenire e la valenza estetica di alcune sue immagini.
‒ Davide Dal Sasso
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati