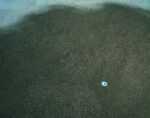Realizzare una mostra di successo oggi. Intervista a Danilo Eccher
Si intitola “Dream” la mostra che sta per inaugurare al Chiostro del Bramante di Roma. Curata da Danilo Eccher, è l’ultimo capitolo della trilogia che ha visto protagoniste “Love” ed “Enjoy”.

Dopo Love ed Enjoy apre al pubblico il 29 settembre Dream, ultimo capitolo della trilogia di mostre curate da Danilo Eccher al Chiostro del Bramante di Roma. Si tratta di una nuova super collettiva che riunisce artisti notissimi (tra gli altri Christian Boltanski, Anish Kapoor, Mario Merz, Giovanni Anselmo, Wolfgang Laib, Ettore Spalletti, Doris Salcedo, Luigi Ontani, Bill Viola) e che sembra avere tutte le carte in regola per raggiungere e superare il successo delle due mostre precedenti. Dream promette un percorso espositivo più che mai immersivo, tra passerelle sospese fra le opere di Kate McGwire e Henrik Håkansson e ambienti avvolgenti come quelli di Tsuyoshi Tane, Ryoji Ikeda e James Turrell. Danilo Eccher ci ha raccontato qualcosa di più della mostra, fra esperimenti allestitivi e potere dei social network.
Cosa ci puoi dire di Dream?
Dream è la terza parte di una trilogia sull’uomo che è iniziata due anni fa con la mostra Love ed è proseguita lo scorso anno con Enjoy. Il tema è il sogno, ma declinato secondo una specifica lettura, quella del viaggio ‒ così come l’amore in Love era letto sul piano dell’ambiguità e il divertimento in Enjoy attraverso i meccanismi della partecipazione.
Non si tratta quindi di una mostra specifica sull’idea di sogno, ma di una sua rappresentazione che tocca le idee di spirito, emozione, incanto. Il percorso si snoda fra le opere di venti artisti, a partire da una spiritualità terrestre, fatta di elementi fisici e naturali, per elevarsi via via a una spiritualità pura, di colore puro. La prima sala sarà dedicata ad Anselm Kiefer e l’ultima a James Turrell.
Quali sono i fili conduttori in questa trilogia di mostre?
Ci sono alcune costanti, per esempio nella scelta degli artisti: già nelle mostre precedenti accanto all’“ossatura” del percorso espositivo, costituita da un gruppo di artisti molto affermati a livello internazionale, proponevo sia artisti più giovani sia artisti dalla grandissima forza visiva ma parzialmente dimenticati. Nella mostra scorsa era il caso di Pietro Fogliati, in questa ci sarà Claudio Costa. Altro importantissimo elemento è poi lo stesso spazio del Chiostro del Bramante. Già far dialogare l’arte contemporanea con un edificio storico è di per sé sempre difficile, ma in questo caso specifico io mi trovo a lavorare in una delle più prestigiose e significative architetture rinascimentali, ed è evidente che in questo spazio non è possibile mettere opere a caso, bisogna che ogni lavoro sia in grado di “reggere” l’architettura. Per questo motivo molte delle opere sono site specific, pensate e realizzate per il Chiostro.

Christian Boltanski, Le Théâtre d’Ombres, 1985-90. Courtesy l’artista
Ci puoi fare qualche esempio?
Mi viene in mente il lavoro della giovane argentina Alexandra Kehayoglou, che trasformerà le scale del Chiostro in un grande paesaggio ispirato alla Patagonia. Non dico altro per non rovinare la sorpresa. Infine, è un punto fermo l’impegno della DART, l’istituzione che gestisce il Chiostro del Bramante, che investe non poche risorse e si occupa della grandissima mole di lavoro che un progetto come Dream può creare; senza la professionalità e il coraggio della DART e in particolare della famiglia De Marco il successo della trilogia non sarebbe stato possibile.
Quali sono le novità in Dream?
Durante l’allestimento di Dream sono accompagnato da una piccola classe di cinque persone, che può vedere come viene allestita una grande mostra e come lavorano alcuni degli artisti coinvolti. La classe non deve né può fare alcun tipo di lavoro, ma ha l’opportunità di scoprire cosa vuol dire montare un’esposizione di questa portata. Penso che sia una bella chance per un aspirante curatore, non è un caso che per cinque posti siano arrivate più di duecento domande.
E a livello di allestimento? In che modo hai approcciato questa trilogia di mostre?
Per me uno degli aspetti più affascinanti di questa trilogia deriva proprio dalla ricerca sull’allestimento, sulla scrittura visiva della mostra, che è uno degli elementi fondamentali del procedere critico. Ho iniziato anni fa a occuparmi del tema dell’allestimento a livello teorico e ho sviluppato la mia ricerca alla GAM di Torino, riorganizzando, per la prima volta in Italia, le collezioni su area tematica e non più cronologica. Ora lavoro al recupero di alcune esperienze della fine degli Anni Sessanta, quando le mostre erano molto fitte, per certi versi persino caotiche. L’esempio più noto è When attitudes become forms curata da Szeemann nel ’69, riproposta da Celant nel 2013 alla Fondazione Prada, ma quel genere di allestimento era tipico di quegli anni, come dimostra la mostra di Ugo Nespolo nel ’68 alla galleria Schwarz curata da Pierre Restany, che avevamo ripreso alla GAM di Torino nell’ambito del progetto Surprise nel 2012. Si tratta di una scrittura visiva molto densa, che negli Anni Ottanta Novanta si è persa nella dimensione più dilatata del white cube.
Qual è la tua idea, dunque?
La mia idea è reinterpretare queste esperienze aggiungendo un elemento nuovo, l’elemento narrativo, che è quello determinante della nostra attualità. Quello che cerco di realizzare è una mostra che sia un’unica grande opera, all’interno della quale i singoli lavori diventano anime pulsanti di un unico percorso creativo e narrativo, attraversato dal visitatore.

Giovanni Anselmo, Mentre la terra si orienta, 2002-06. Courtesy l’artista e Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea. Installation view at Galleria d’Arte Moderna, Bologna 2006. Photo Ela Bialkowska
Come ti spieghi l’enorme successo riscosso dalle precedenti Love ed Enjoy, soprattutto fra i giovani, che probabilmente non conoscono molti degli artisti coinvolti?
È vero, queste mostre hanno avuto un grande successo di pubblico, 150mila la prima e 170mila la seconda, e più dell’80% dei visitatori era formato da pubblico dai 15 ai 25 anni. Credo sia un dato straordinario, che prova l’esistenza di un enorme desiderio d’arte contemporanea soprattutto da parte dei giovani: non è vero, quindi, che i ragazzi non amano l’arte, è che vogliono qualcosa di nuovo, di diverso, vogliono sentirsi in qualche modo partecipi dell’esperienza dell’arte. Anche sotto questo profilo mi sembra di percepire una similitudine con molte esperienze della fine degli Anni Sessanta, quando le mostre erano collegate alle performance ed erano molto vicine all’elemento teatrale, molto vicine all’esperienza.
Che tipo di arte interessa ai giovani, secondo te?
La visione comune vuole che i giovani siano interessati solo all’arte degli artisti giovani, per una vicinanza generazionale, e anche questo in realtà non è vero, quello che interessa è una lettura nuova dell’opera d’arte, un principio che si può estendere anche all’arte classica o alle collezioni museali antiche. Dopodichéé esiste anche un elemento più strettamente legato alla comunicazione: queste mostre hanno avuto grande successo perché si è puntato moltissimo sul web, sui social media, sulla possibilità di circuitare le fotografie delle opere.
Come ti poni rispetto ai social media? In un certo senso determinano una diversa fruizione delle opere.
Rispetto ai social media da parte mia c’è soprattutto una grande sorpresa, perché malgrado io li usi e ne conosca la struttura, mai avrei pensato che avessero un potere così suadente in un campo che non è la politica o lo sport, ma la cultura. Non pensavo avessero questo peso e invece mi sono accorto che hanno una capacità di coinvolgimento incredibile. Sono rimasto sbalordito, visitando la mostra degli Ambienti spaziali di Lucio Fontana all’HangarBicocca qualche mese fa, nello scoprire, davanti a opere che per me sono mostri sacri, masse di ragazzi che si facevano continuamente selfie, in ogni spazio, soli, in gruppo, con il fidanzato. Ero stupefatto dal potere di questi strumenti in un contesto così complesso, in un allestimento anche molto impegnativo dal punto di vista organizzativo. Mi aspettavo di più i selfie nel labirinto di Leandro Erlich [alla mostra Enjoy, N.d.R.], e invece anche in opere concettualmente complesse come gli Ambienti di Fontana funzionano perfettamente.
Quindi la comunicazione via social ha avuto e avrà un peso determinante?
Sì, e poi c’è un altro elemento della comunicazione che mi ha incuriosito molto e confesso di fare ancora difficoltà a capire. Per anni ho inserito nei manifesti e negli inviti i nomi degli artisti e ho sempre pensato che fossero determinanti per attrarre il pubblico. In queste mostre, invece, non abbiamo messo alcun nome di artista, il titolo era solo Love, poi Enjoy, e ora Dream. E questi titoli, scelti dall’ufficio comunicazione, hanno aiutato molto, mentre i titoli che dò io solitamente alle mostre sono molto più ermetici e molto meno di successo! Una titolazione più aperta, più disinvolta e anche meno impegnativa evidentemente aiuta un pubblico che è curioso ma che non si sente preparato a una titolazione più precisa, o al nome dell’artista che “devi” conoscere.

Anselm Kiefer, Untitled, 1995. Courtesy Lia Rumma
Questo è un grande problema dell’arte contemporanea, molta gente si sente in ansia a entrare in un museo o in una mostra perché si sente giudicata, magari non conosce e ha paura di sbagliare.
Infatti, io credo che questa forma di generalità abbia aiutato molto quel pubblico che ha timore davanti a un’opera d’arte che non conosce, a un artista che non conosce, a una situazione storica che non conosce. E questo pubblico è spesso quello dei giovani, che non ha ancora formato una consapevolezza critica. Se non si attira questo pubblico invitandolo ad avvicinarsi all’arte contemporanea, si perde il pubblico più importante, perché il pubblico dei giovani di oggi è il pubblico del domani.
Oggi sei un curatore indipendente, ma sei stato direttore di diversi musei d’arte contemporanea in Italia. Che ne pensi della situazione museale odierna?
I musei negli ultimi dieci anni sono profondamente cambiati, è cambiata la politica museale e la strategia nella gestione museale. Da un lato, grazie all’università, alle accademie e alle stesse istituzioni, si è formata una classe di giovani curatori e direttori già molto capaci, e questo ha sicuramente migliorato il livello qualitativo, dall’altro lato la crisi finanziaria, che ha massacrato la politica culturale, ha ridotto enormemente il potere museale in Italia soprattutto nell’arte contemporanea. La risposta purtroppo, secondo me, è stata abbassare il livello, creando l’illusione, tra l’altro, che tutti possano fare gli artisti. Non è vero che tutti possono fare gli artisti, come non è vero che tutti possono fare i piloti di jet o i cardiochirurghi, la democrazia nell’arte significa che l’arte deve essere per tutti, non che tutti possono farla. Purtroppo questo non è sempre chiaro.
Prossimi progetti dopo Dream?
Adesso sono concentrato su una grande mostra per i musei asiatici dedicata all’Arte Povera, che partirà a Manila nel febbraio 2019 e si sposterà molto probabilmente a Kuala Lumpur in giugno. Anche in questo caso sarà una mostra anomala, in quanto sarà un grande “paesaggio” italiano nel quale le opere andranno a sovrapporsi e a dialogare fra loro in un’unica grande installazione.
‒ Sara d’Alessandro Manozzo
 1 / 5
1 / 5
 2 / 5
2 / 5
 3 / 5
3 / 5
 4 / 5
4 / 5
 5 / 5
5 / 5
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati