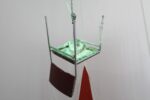Intervista a John Bock. L’arte è come un dito in un occhio
Chiama le sue performance "conferenze", è cresciuto in una fattoria ed è diventato famoso negli Anni Novanta. Ora ha una personale alla Fondazione Prada di Milano e questo pomeriggio, 8 settembre, farà appunto una performance. L’abbiamo intervistato.

Chiama le sue performance “conferenze”, è cresciuto in una fattoria ed è diventato famoso negli Anni Novanta proponendo una videoarte basata sull’incontro fra installazione e azioni teatrali. Conteso dalle grandi kermesse artistiche e dai musei internazionali, John Bock (Gribbhom, 1965) fonda la sua poetica sul neologismo da lui coniato, “summenmutation”, che descrive il ciclo di riutilizzo degli oggetti dentro le installazioni che accolgono le sue azioni slapstick e non-sense. Con esse l’artista tedesco ha costruito un’estetica originale, che va oltre il bello e il sensato, sintetizzando i combines di Rauschenberg con il Leaving Theater.
La sua nuova mostra personale alla Fondazione Prada a Milano, The Next Quasi-Complex (fino al 24 settembre), presenta questa estetica da self made artist e del recupero creativo degli oggetti; in essa Bock crea un’installazione site specific composta da installazioni storiche, scena perfetta per esprimere ambizioni scultoree che risentono fortemente del suo amore per il cinema e per la narrazione horror. Il suo punto di vista, non convenzionale e stralunato, mette insieme la comicità di Buster Keaton e la suspense codificata da Alfred Hitchcock. Se gli chiedi che cos’è l’arte, lui risponde “un dito nell’occhio“, citando Stanlio e Ollio. La mostra ruota attorno ai lavori acquistati dalla Collezione Prada: il set di Lütte mit Rucola (2006) e l’installazione When I’m looking into the Goat Cheese Baiser (2001) che oggi 8 settembre ospiterà una nuova performance dell’artista.
Lo abbiamo incontrato per parlare del cinema, dell’architettura e della musica che, al posto dell’arte, lo ispirano da oltre trent’anni.

John Bock. The Next Quasi-Complex. Exhibition view at Fondazione Prada, Milano. Photo Jacopo Farina. Courtesy Fondazione Prada
Fin dai primi Anni Novanta, il tuo lavoro adotta uno stile che trasforma il serio in faceto: è davvero questo il tuo obiettivo?
Uso l’umorismo per mostrare il lato triste delle cose, come Buster Keaton, comico per eccellenza perché non ride mai, attraversa miriadi di problemi mantenendo un distacco da tutto ciò che lo circonda. Lui è molto più triste di Charlie Chaplin, il suo umorismo nero è una risposta all’utopia, mostra il lato oscuro delle cose. Io mi sento vicino a lui, nella mia arte penso al dolore, al senso di vuoto e alla solitudine.
Però il pubblico si diverte alle tue performance.
Creo situazioni e ambienti per stupire, per contraddire le aspettative. Anche gli oggetti che creo hanno una nuova luce, voglio mostrare loro cosa può fare un oggetto.
E cosa può fare?
Ogni mio oggetto è come un diagramma tridimensionale, mostra una serie di connessioni di interdipendenza tra elementi non sottoposti al principio di causalità.
Ti sei definito uno storyteller che usa gli oggetti e nelle performance usi e sei usato dai tuoi oggetti.
Questa è la forma di teatro che amo fare, in cui gli oggetti non hanno paura di essere altro da sé e sono l’opposto della scultura glamour, come per esempio quella di Jeff Koons.
Le tue installazioni sono mondi, sembrano pervasi da una logica ma non si sa quale sia.
Voglio che siano come il film Blade Runner, una combinazione di architettura, tubi, nebbia, cibo cinese ed edifici utopici. Cerco di unire il vecchio e il nuovo, il passato e il futuro.
Come ha inizio la loro costruzione?
Parto dai mercati delle pulci, cerco oggetti vissuti che conservino ancora un tocco umano. Non ho paura di questi oggetti che non brillano più. Brillantezza significa distanza, è come se l’oggetto ti dicesse: sono perfetto, non toccarmi. I miei oggetti hanno rotture, polvere e sporcizia su di loro, i diversi significati che assumono possono sorprendere sia me, sia il pubblico.

John Bock, Klar wie Brühe, 2018 (dettaglio). Photo Jacopo Farina. Courtesy Fondazione Prada
Un pubblico sempre più coinvolto negli anni, che senso ha per te?
Il pubblico è il motivo per cui ho iniziato le mie azioni, volevo stargli più vicino. Non amo lavorare in solitudine, nello studio, voglio vivere nella galleria o nel museo mentre creo i miei oggetti.
Una forma d’arte in progress.
A Documenta 11 a Kassel, nel 2002, ho passato settantacinque giorni nell’installazione e il pubblico veniva a vedere cosa stavo creando, senza paura. Mi piace quando non c’è paura.
Anche l’arte, come il teatro di Bertolt Brecht o del Living Theater, ha una quarta parete da abbattere?
Davanti all’arte devi sempre fare due passi indietro e usare la tua cultura per riuscire a capirla. Non so se sia una parete, ma ci assomiglia molto.
Come decidi quando una tua installazione è finita?
Quando avviene quello che io chiamo “summenmutation”, quando si è creata una mutazione degli oggetti dopo che vi ho realizzato una performance o dopo che vi ho girato un film.
Di cosa si tratta? È sempre una relazione tra la scultura e il video?
Di una mutazione senza fine, nella quale si aprono continuamente nuovi campi di relazione. Nel caso di Lütte mit Rucola, l’installazione era il set del film e ora la trasformo per allestire una performance che il pubblico potrà vedere da un balcone, come in un film girato con la tecnica del top shot o come quando guardi una foto.

John Bock, Lütte mit Rucola, 2006 (dettaglio). Photo Jacopo Farina. Courtesy Fondazione Prada
La tua arte sembra riecheggiare alcuni modelli, da Schwitters a Fischli e Weiss o Paul McCarthy. Chi ti ha influenzato maggiormente?
Non sono molto influenzato dagli artisti, ma Edward Kienolz è stato molto importante per me: ho visto la sua installazione Roxy in Germania, era buia, popolata da strane figure e vecchi mobili. E poi quell’odore. I visitatori entravano in un mondo e mi sono detto: “Ecco qualcosa di eccezionale”. Comunque mi rifaccio più a registi e architetti. Mi piacciono i film di Darren Aronofsky, Buster Keaton, Lars von Trier, adoro i primi film di John Carpenter, il loro lato oscuro. Mi piacciono architetti come Shigeru Ban e Rem Koolhaas, il Bauhaus.
Nel 2016 giri Hell’s Bells, un film western molto sui generis. Qual è il tuo rapporto con la narrazione?
Mi piace entrare dentro i sistemi dei vari generi narrativi per creare scompiglio, capovolgendone le regole e portando dentro la storia molti oggetti speciali e una recitazione particolare, voglio torcere sempre più il linguaggio per arrivare a toccarne gli estremi. Il prossimo film sarà sulla superstizione, in un villaggio tedesco nel X secolo.
Le tue “conferenze” però appaiono come strani giochi infantili.
Devi immaginare un bambino che gioca da solo in una camera dove sua madre ha dimenticato di spegnere il ferro da stiro; il bambino si alza in piedi e vuole toccare il ferro. Questa è la mia arte, perché il bambino pensa che sia divertente, si alza e mette la mano sul ferro e poi: taglio.
E cosa succede allora?
Sta al pubblico scoprirlo.
C’è molta suspense nei tuoi film più recenti, come nei film di Hitchcock.
Uso il taglio per non dire tutto, in passato parlavo troppo, ora meno oppure pronuncio frasi sbagliate.

John Bock. The Next Quasi-Complex. Exhibition view at Fondazione Prada, Milano. Photo Jacopo Farina. Courtesy Fondazione Prada
Tu insegni scultura a Karlsruhe, ma nel tuo lavoro la scultura da sola non esiste.
Infatti insegno “non solo scultura”, un’arte basata sull’interdipendenza, che non risponde alla logica del “tu sei cattivo e io sono buono”.
Lütte mit Rucola è un film sulla tortura di un uomo.
È un film sull’estetica dell’uccidere e si ispira al cinema horror di Halloween, Venerdì 13, Psycho o Hannibal Lecter. Ogni film d’azione è basato sull’uccisione.
Che rapporto hai con l’arte?
A volte ne avverto il peso sulle spalle. Mi piace più la moda: Comme des Garçons, Yohji Yamamoto o Junya Watanabe.
Meglio usare tutti i tipi di arte.
Anche la musica: Stockhausen, Penderecki, Arvo Pärt, Luigi Nono. Quando penso a un mio film, penso alla sua colonna sonora. Penderecki ha fatto la migliore musica horror che abbia mai sentito.
Come gestisci il caos, l’entropia e l’ordine che si intrecciano nelle tue opere?
L’entropia è la mia preferita, mi piace creare sistemi in cui qualcosa è sbagliato. Il caos buono è lo scompiglio di un bel sistema. Pensa a un film come Velluto blu di David Lynch: lui torna a casa, con gli uccellini che cantano, una bella ragazza, gente amichevole intorno e all’improvviso arriva Frank, Dennis Hopper, il cattivo che porta un male crescente in un mondo da lieto fine. Mi piace quando il male arriva in un mondo da lieto fine.
Non ami il lieto fine?
Sì, ma non in questo mondo, semmai dopo. Preferisco decisamente la distopia all’utopia.
In cosa credi?
Credo nel singolo individuo, non credo invece nella società che è una struttura. Lo stesso vale per la cultura, che è l’opposto dell’arte. La cultura è un sistema di giudizio per dire: “Questo è un bravo artista, fa soldi e le sue sculture non sono pericolose“.
E l’arte?
L’arte è un colpo: ti colpisce sulle braccia, sui fianchi, sulla schiena. L’arte è come un dito in un occhio, hai presente Stanlio e Ollio?

John Bock. The Next Quasi-Complex. Exhibition view at Fondazione Prada, Milano. Photo Jacopo Farina. Courtesy Fondazione Prada
Torniamo all’impegno sociale.
Mi interessa la persona, non la società, che è troppo grande e troppo astratta. Mi basta che alcune persone dicano: “Oh, questo è così diverso dal nostro mondo, ma mi piace e non so perché mi piace”.
Ti piace mettere disordine nel sistema, la tua potrebbe essere una reazione al mito tedesco della comunità bene organizzata?
Sì, è possibile. Vengo da una fattoria e sono figlio di un fattore. Lo Stato gli disse un giorno: “Devi produrre molto più latte, devi comprare più terra”. Due anni dopo disse: “Scusate, ci sono i tagli, ora dovete produrre meno latte”. Così i contadini si sono impoveriti, mentre il sistema godeva di latte a buon mercato meno costoso della Coca-Cola. Ma per produrre un litro di latte serve la terra, tre anni per crescere le mucche, che poi si ammalano. Questo è successo quando ero bambino ed è per questo che non mi fido della società, per questo la distopia è il mio potere.
E l’utopia?
Mi piace, mi piace ad esempio l’arte di Rirkrit Tiravanija o l’arte di Andrea Slominski, ma io posso produrre solo distopia. Vorrei che un giorno facessimo una mostra insieme: l’arte buona e l’arte triste.
– Nicola Davide Angerame
 1 / 13
1 / 13
 2 / 13
2 / 13
 3 / 13
3 / 13
 4 / 13
4 / 13
 5 / 13
5 / 13
 6 / 13
6 / 13
 7 / 13
7 / 13
 8 / 13
8 / 13
 9 / 13
9 / 13
 10 / 13
10 / 13
 11 / 13
11 / 13
 12 / 13
12 / 13
 13 / 13
13 / 13
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati