Ribelle senza maschera. Albert Camus a sessant’anni dalla scomparsa
Un incidente stradale spezzò la sua esistenza ad appena quarant’anni. Era il gennaio del 1960, ma anche a distanza di decenni, la sua opera e il suo pensiero sono ancora attuali. Anche se sembrano passati di moda, perché scomodi, troppo stoici e severi per i costumi di oggi. Eppure, Albert Camus resta uno dei pensatori più profondi dell’Europa del secondo Novecento.

Non la solitudine disperante e disperata di Edward Hopper, quella che cerca l’abbandono in squallide stanze di motel o luridi bar di periferia per autodistruggersi lentamente, ma quella dell’individuo in rivolta, “le cui azioni e opere ogni giorno negano le frontiere e le più grossolane apparenze della storia”. Di colui che va oltre, che inventa nuovi linguaggi, che apre nuovi sentieri, senza alzare la voce, ma con pazienza e umiltà, fiero di essere se stesso. Una missione che oggi appare straordinaria, e uno di quei paradossi che di quando in quando regala l’esistenza, l’esistenzialista Albert Camus ((Dréan, 1913 – Villeblevin, 1960) è solo al pari di Sant’Antonio che, sulla spiaggia di Rimini, predica ai pesci, così come lo ritrasse Girolamo Tessari nel XVI secolo: lontano dalla folla, eppure più vicino che mai, solleva con la dialettica la legge morale, ne spezza i confini, è uomo di rinascita e di libertà. Un esempio di resistenza civile, e tipi così sono sempre stranieri, anche e soprattutto in patria.
UNO STRANIERO IN CADUTA
Comunista atipico, malvisto per il suo oscillare fra Trotzkij e l’anarchia (in realtà manifestazioni di libero pensiero), poco incline all’idea di massa e di partito, per la sua indipendenza e coerenza di pensiero lo si può accostare al nostro Giovannino Guareschi (altro celeberrimo straniero in patria). E come lui osservava con amarezza il vuoto che si apriva nelle coscienze degli individui, con la medesima piega amara che negli Anni Venti aveva contraddistinto i pittori della Neue Sachlichkeit: le folle urbane di Grosz, dove la gente si sfiora di fretta, senza riconoscere nessuno né essere riconosciuta da nessuno, stranieri fra vicini di casa o colleghi di lavoro, raccontano le stesse lontananze fatte d’indifferenza che incontra il protagonista de Lo straniero, e le stesse dolorose ipocrisie di quei dialoghi narrati ne La caduta. Ancora una volta, spuntano le maschere di pirandelliana memoria, si confondono le identità, le epoche storiche, in una sorta di teatro arlecchinesco come solo Severini sapeva dipingere.

Georg Baselitz, Ribelle 1965 © Georg Baselitz 2017. Photo Friedrich Rosenstiel, Colonia
LA PESTE, IERI E OGGI
Non la giustiziera Morte Nera degli affreschi medievali, mandata da Dio a sterminare i peccatori; la peste di Camus è assai più sottile e mortifera. Quel romanzo non è soltanto una riflessione sull’assurdità dell’esistenza e la precarietà della condizione umana. I bacilli paventati dallo scrittore, infatti, non allignano fra le baracche di Orano o Calcutta, come si potrebbe a torto pensare. Questi bacilli abitano luoghi insospettabili: ad esempio, per guardare in casa nostra, i raffinati (architettonicamente parlando) palazzi di Roma, quelli del potere, con gli inquilini affezionati alle poltrone più tenacemente dei ratti alle fogne. E fuori, l’indifferenza. Si tratta di quella peste che già nel Seicento i Bentvueghels avevano trovato (però senza riconoscerla) nelle taverne romane, fra bari, vagabondi, ladri, lenoni e puttane, e che un secolo prima Pietro Aretino aveva immortalato nei suoi sonetti e commedie; ma sul momento, tra i fasti del Rinascimento, si pensò allo scherzo di un caratteraccio pazzerello e nemmeno i cardinali corbellati provarono il minimo risentimento. Invece la peste della viltà allignava, assieme a quella della corruzione, dell’avidità, della viltà, e con essa si radicavano il fatalismo, l’amarezza, la disperazione. E muoiono le coscienze.
LOTTA NON ARMATA
Un degrado da combattere ogni giorno, ma poiché la società non ci riesce in maniera efficace, sta alle iniziative del singolo, del solitario, quello che, per citare Leopardi, “a sollevar s’ardisce gli occhi mortali incontra al comun fato”. E anche se la lotta fosse solo illusione, “senza le illusioni non ci sarà quasi mai grandezza di pensieri, né forza e impeto e ardore d’animo”. Come per il poeta di Recanati, un equivoco fece passare Camus per un pessimista o un nichilista, quando in realtà la sua fiducia nella forza del singolo non aveva limiti. Lo chiarì nei Discorsi di Svezia, scritti per la cerimonia del Nobel di cui fu insignito nel 1957.
Camus è un ribelle all’assurdo, un lottatore di pensiero, come Hans Hartung, Edmund Kalb, Georg Baselitz, nelle cui pitture si ritrova le medesima ostinazione. Camus è un rinnovato Perseo che lotta a colpi di spada/penna contro le insensatezze morali dell’animo umano, con lo stesso sguardo fiero che gli prestò Cellini, pronto a morire per la verità.
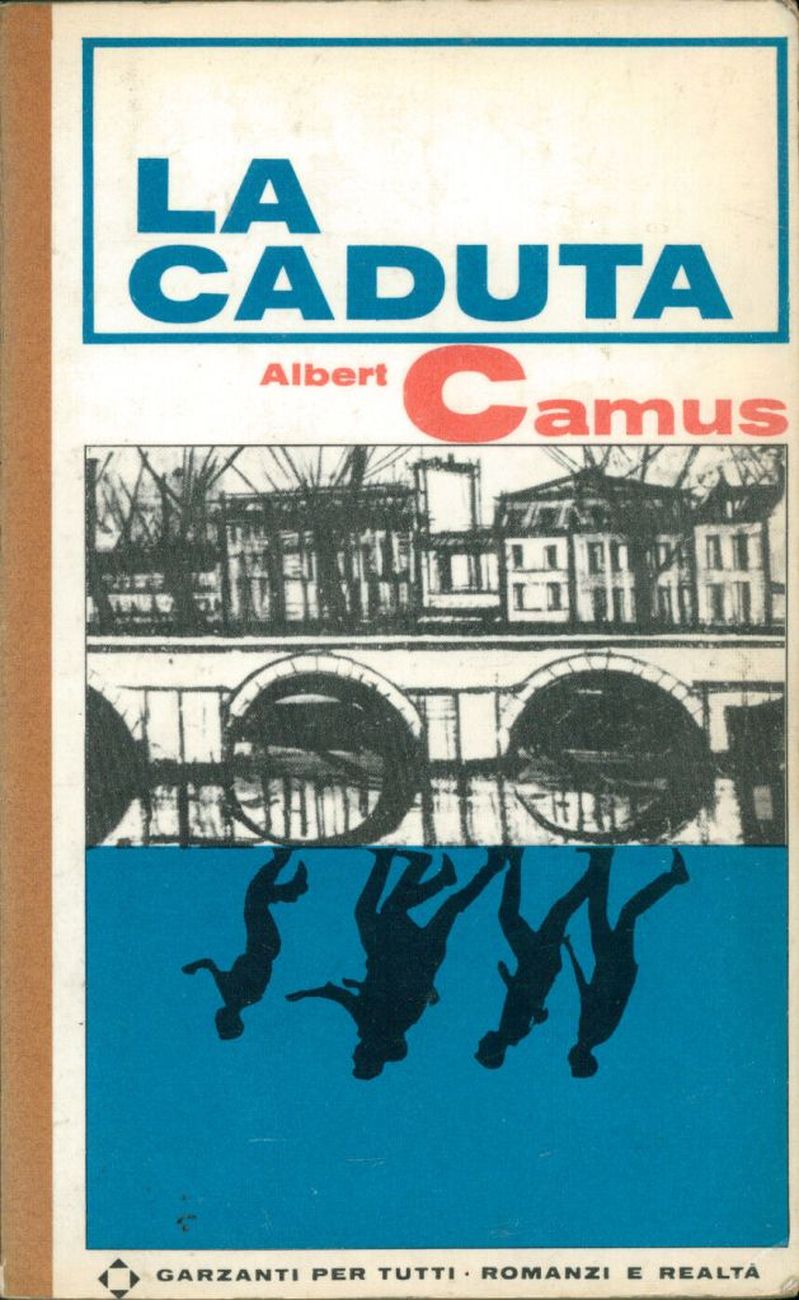
La prima edizione italiana de “La caduta” di Camus, Garzanti, 1966
BIANCO E NERO
Se la scrittura di Lautreamont contiene tutti i colori dell’universo, Camus scrive in “bianco e nero”, ma un bianco e nero stupendo, esistenzialista, carico di memoria anche se ingannevole, struggente come quello delle fotografie di Astrid Kirchherr (che iniziava la carriera, ironia della sorte, proprio quando Camus moriva). Ma stavano aprendosi gli Anni Sessanta, il decennio della massa e dello spettacolo, del quarto d’ora di celebrità, degli scontri di piazza, della pubblicità e del consumismo. E il popolo scelse, o s’illuse di poterlo fare.
‒ Niccolò Lucarelli
 1 / 6
1 / 6
 2 / 6
2 / 6
 3 / 6
3 / 6
 4 / 6
4 / 6
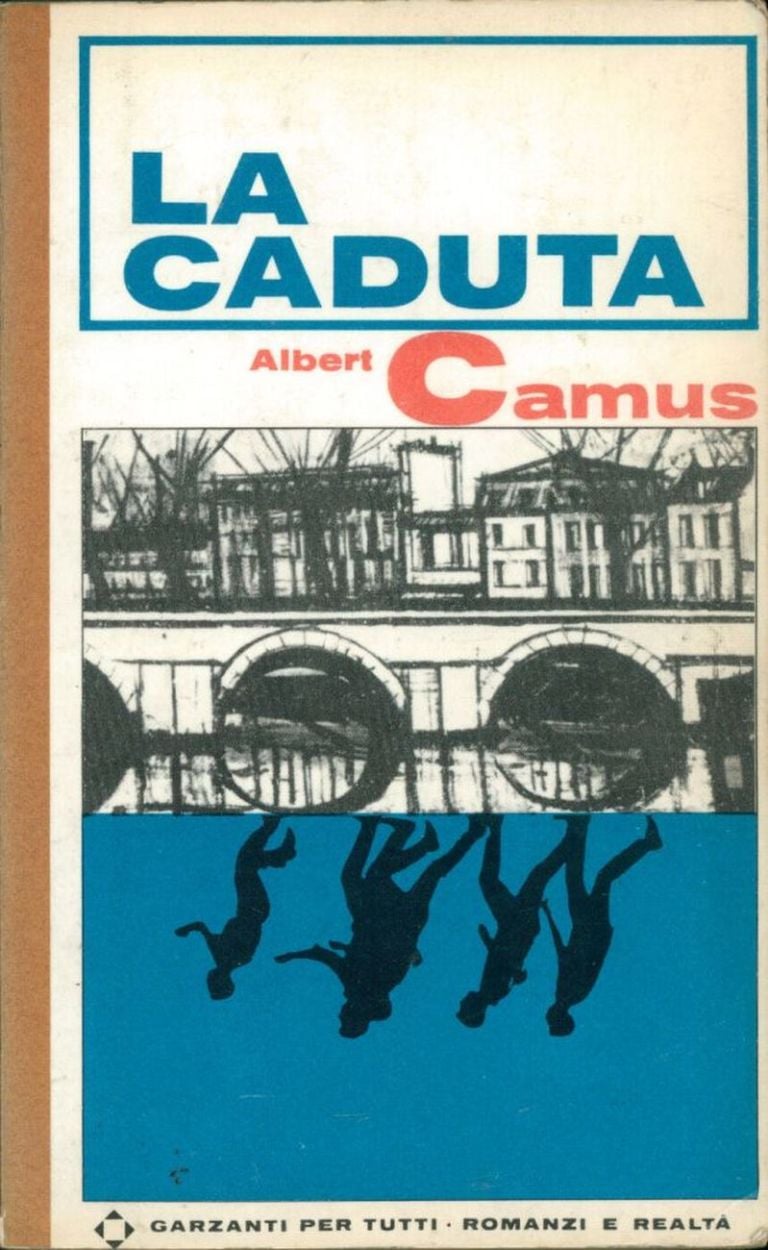 5 / 6
5 / 6
 6 / 6
6 / 6
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati











