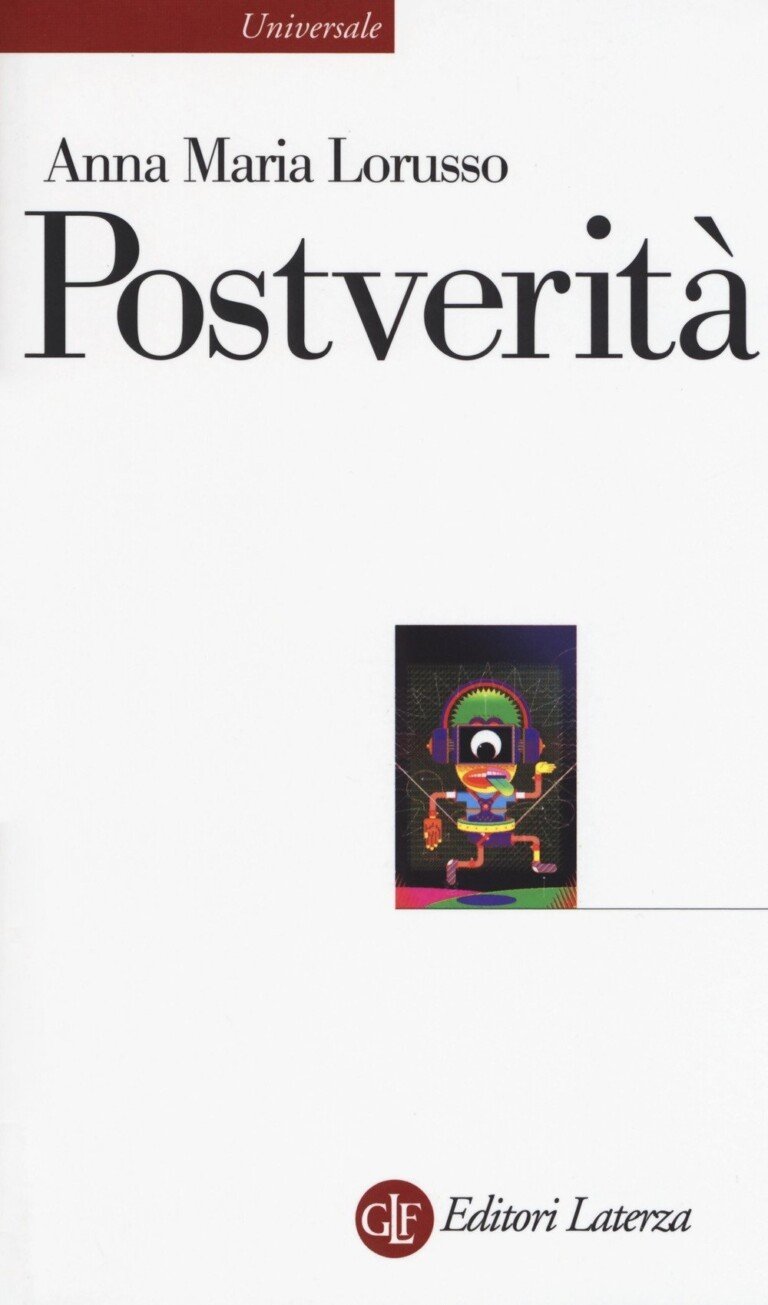Cultura, buon senso e senso comune. Intervista a Anna Maria Lorusso
Che differenza c’è fra senso comune e buon senso? E che ruolo hanno gli stereotipi e i luoghi comuni rispetto a tutto ciò? Ne abbiamo parlato con Anna Maria Lorusso nell’ambito della rubrica “Dialoghi di Estetica”

Anna Maria Lorusso (1973) insegna Semiotica presso l’Università di Bologna. Dal 2017 al 2021 è stata Presidentessa dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici; è stata visiting professor negli Stati Uniti, in Cile, in Australia, in Canada e in Argentina. Le sue ricerche vertono sulla dimensione retorico-discorsiva della cultura, con particolare attenzione per la memoria e l’eredità culturale, le forme delle narrazioni collettive, la formazione e la traduzione di stereotipi e luoghi comuni, le forme di “popolarizzazione” della storia attraverso i diversi media. È l’autrice di Semiotica del testo giornalistico (con Patrizia Violi, Laterza 2004); Metafora e conoscenza (Bompiani, 2005); La trama del testo. Problemi, analisi, prospettive semiotiche (Bompiani, 2006); Umberto Eco. Temi, problemi e percorsi semiotici (Carocci, 2008); Semiotica della cultura (Laterza, 2010); Postverità. Fra reality tv, social media e storytelling (Laterza, 2018). Questo dialogo si sofferma su alcuni dei temi che affronta nel suo ultimo libro, L’utilità del senso comune (il Mulino, 2022).

Anna Maria Lorusso
INTERVISTA AD ANNA MARIA LORUSSO
Alla base della tua indagine hai posto la differenza tra senso comune e buon senso. Come possiamo intendere ciascuno e perché è così importante questa distinzione per il tuo studio?
Ho voluto distinguere queste due categorie perché spesso vengono usate come sinonime, ma voci celebri (come quella di Manzoni, che nei Promessi sposi scrive: “Il buon senso c’era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune”) le distinguono e le oppongono. Di certo, non c’è nella letteratura filosofica, sociologica, critica, una convergenza programmatica sulla loro definizione; mi è parso però di cogliere una convergenza de facto fra molti autori: il senso comune ha una dimensione sociale, il buon senso una dimensione individuale. A partire da questa caratterizzazione, definisco il senso comune come un patrimonio di sapere e credenze condiviso all’interno di una certa cultura; il buon senso come una forma di giudizio (come tale individuale) che al senso comune si appella.
La prospettiva teoretico-archeologica che tracci nella prima parte del libro invita a riflettere sul rapporto tra senso comune, esperienza e realtà. Queste ultime sono naturalmente influenzate da mutevolezza e variabilità. Tenendo conto di ciò, come si caratterizza il rapporto con il senso comune?
La realtà è certamente mutevole ma l’esperienza, in alcune sue categorie di base, è condivisa, ripetitiva, prevedibile. Anzitutto la componente sensoriale e percettiva che sta alla base dell’esperienza rende il nostro stare al mondo, a un certo livello, condiviso. E questo livello sensibile è alla base del senso comune, che – non dimentichiamolo – è un senso, per Aristotele una sorta di radice comune dei cinque sensi. Appellarci a questo livello percettivo di base consente alla nostra attività cognitiva di avere una base condivisa e qualcosa di sicuro da non dover e poter mettere in discussione. E questo “appello” parte da Aristotele e arriva fino al ’900, ai truismi di George E. Moore ad esempio. In secondo luogo, l’esperienza è regolare anche in virtù di habitus e predisposizioni interpretative che si ripetono e che vanno a costituire dei presupposti fuori discussione, quasi degli automatismi, non solo delle azioni ma del pensiero. Questi automatismi, ovvero idee fuori discussione che sembrano (e sottolineo “sembrano”) avviare ma non entrare nel circuito interpretativo, sono i tasselli del senso comune.
Uno degli aspetti che hai messo in risalto riguarda l’evidenza segnica della realtà. Che ruolo ha la dimensione interpretativa rispetto alla natura del senso comune?
Il senso comune è una risorsa interpretativa essenziale per l’uomo, sia in quanto individuo che in quanto membro di una comunità. È essenziale perché consente all’attività interpretativa, facilmente pronta a deragliare come esercizio libero di individualismo, di avere dei modelli di riferimento, degli schemi valoriali e narrativi, delle “mappe” per orientarsi nella molteplicità del reale. Il senso comune è in sé materia interpretativa, esito di interpretazioni consolidate di vecchia data, e al contempo risorsa interpretativa, strumento per gestire le interpretazioni a venire. Esso ha così una funzione di ancoraggio (in ciò che è già stato avallato dall’accordo), senza per questo sottrarre pensiero e comunicazione alla possibilità del mutamento, della novità interpretativa. Certo, il senso comune ha una vocazione semplificatoria, ma questa vocazione non è da trascurare, o da snobbare: se non riuscissimo a semplificare (a un certo livello) il reale, saremmo sopraffatti dalla sua eterogeneità e dalla sua complessità. Il senso comune ci aiuta ad adeguare le nostre interpretazioni alla realtà e alla cultura in cui viviamo – come anello di mediazione, sintonizzazione.

L’utilità del senso comune (il mulino, 2022)
STEREOTIPI E CULTURA
Nel quadro di una riflessione sulle dinamiche culturali, osservi che gli stereotipi possono essere considerati – sul piano delle pratiche sociali e negli usi del linguaggio – utili risorse per la creazione del senso comune. In alcuni casi, però – penso, per esempio, agli usi del linguaggio nella questione di genere –, possono presentarsi comunque alcune difficoltà.
Nel mio libro ho voluto solo sfiorare la questione degli stereotipi; la letteratura su questo argomento è enorme e in più ambiti disciplinari. Certamente, comunque, anche dagli studi psicologici sappiamo che gli stereotipi sono utili, o meglio essenziali, proprio per gestire la complessità della realtà. Il senso comune, dunque, può farvi utilmente ricorso. Naturalmente, però, lo stereotipo è una immagine ripetuta e semplificata, e come tale richiede sempre una vigilanza critica: di fronte agli eccessi di semplificazione, lo stereotipo va sorvegliato. E nella contemporaneità lo vediamo chiaramente: pensiamo agli stereotipi sui migranti, o sui meridionali, o agli stereotipi di genere. Siamo in un periodo di rapido cambiamento sociale, e gli stereotipi sembrano non riuscire a stare al passo coi tempi: sono in ritardo. Il problema è che uno stereotipo non cambia rapidamente e non cambia con singoli atti di volontà: non possiamo decidere di sostituire uno stereotipo. Possiamo criticare gli stereotipi, possiamo elaborare modelli e immagini nuove, possiamo raccontare storie diverse in cui i ruoli sono ribaltati (e dico “storie” perché penso che le narrazioni abbiano una potenza radicale), ma prima che lo stereotipo perda la sua presa dovrà sedimentarsi una sensibilità nuova, un senso comune diverso…. Si tratta di processi lenti; pensare di cancellare gli stereotipi con dichiarazioni di principio è pura utopia (semiotica).
Da un punto di vista logico, il senso comune potrebbe essere contraddittorio. Tuttavia, come chiarisci nel libro, pur non basandosi su criteri di verità, esso pretende l’accordo. Come si spiega la normatività sociale che lo caratterizza?
Questo è un punto che mi è molto caro. Il senso comune si legittima nel momento stesso in cui si afferma: deve pretendere di essere condiviso (altrimenti è solo l’insieme di convinzioni di qualcuno, e come tale non può pretendere alla normatività). Funziona quindi sulla base di un principio autolegittimante che non ha criteri di verifica esterni: pretende di essere comune e in funzione di questa pretesa può assumere valore. Se mi appello al senso comune per giustificare la scelta di non presentarsi in un’aula di lezione in costume, sto pretendendo che questo criterio sia universale, ma non potrei trovare un codice in cui questa norma sia scritta, né una ragione “logica”, empirica, per cui se a luglio ci sono 40° non sia opportuno fare un esame in aula in costume da bagno. Faccio come se il criterio fosse condiviso da tutti, e del tutto ovvio, per fare in modo che tale criterio venga rispettato. Come dico nel libro, il funzionamento del senso comune da questo punto di vista ha molti aspetti in comune con il giudizio di gusto kantiano: non c’è nessun principio empirico di verifica per cui una cosa possa da tutti essere giudicata bella; ma il giudizio estetico pretende all’universalità, si impone come se fosse condiviso da tutti. E così è per il senso comune: si impone come se fosse universale, ma non lo è, né è dimostrabile che sia giusto. Ciò detto, proprio pretendendo a questa universalità, riesce a costruire una comunanza: i singoli soggetti si ritrovano, si proiettano, in quella comunità immaginata.
Insieme alla dimensione interpretativa, per il senso comune sono altrettanto cruciali quella critica e quella comunitaria. In modi diversi, entrambe invitano a riflettere sulle pratiche sociali, nonché sugli usi del linguaggio. Come osservi nel libro, esso ci permette di elaborare immagini del mondo e procedere nella classificazione degli oggetti che lo popolano. Quale “configurazione” ha il senso comune alla luce di queste dinamiche?
La ricaduta comunitaria del senso comune per me è fondamentale. Ritrovarci “in un senso comune” significa sentirci parte di una comunità di valori, comportamenti, abitudini – una comunità che non ha base nazionale, sociale, anagrafica, ma che si basa solo su un sentire condiviso.
Questo senso di appartenenza comunitaria funziona anche da senso del limite (che in un’epoca di individualismo e narcisismo esasperati è essenziale): sapere che esistono delle convinzioni di senso comune, dei valori di senso comune, contiene eventuali tendenze interpretative fuori controllo e crea degli “standard”, pone paletti oltre i quali non andare. Il web è pieno, ahimè, di soggetti che sfidano la plausibilità semplicemente per farsi notare, per acquisire una visibilità nello spazio pubblico. Ecco: quando il senso comune viene eccessivamente o ripetutamente aggredito, smentito, sfidato, la “voce sola” narcisista e provocatoria si ritrova fuori dalla comunità discorsiva.

Postverità (Laterza, 2018)
IL SIGNIFICATO DEI LUOGHI COMUNI
Le nostre pratiche sociali, le abitudini, i diversi modi che abbiamo di vivere rievocano spesso anche quelli che siamo soliti chiamare ‘luoghi comuni’: che cosa sono e che rapporto hanno con il senso comune?
Come gli stereotipi, anche i luoghi comuni sono parte del senso comune, ma non lo esauriscono. Nel mio libro in qualche modo cerco di riabilitare e legittimare categorie di cui spesso vediamo solo la rigidità e la semplificazione: stereotipi, luoghi comuni, senso comune (di cui, nel titolo, affermo l’utilità). I luoghi comuni per qualsiasi comunità culturale sono una grande riserva, ce lo ha insegnato la retorica antica parlando di topoi: una riserva di idee, di associazioni concettuali, di trame possibili. Tenere presente questa risorsa è importante per avere a disposizione degli argomenti plausibili, consolidati nella nostra cultura. Il punto è che dei luoghi comuni bisogna essere consapevoli; da questo punto di vista la lezione di Roland Barthes è cruciale: la tendenza ideale non dovrebbe essere a eliminare i luoghi comuni, ma a saperli “abitare” con consapevolezza. In questo modo, riconosceremmo l’utilità del senso comune: sostegno concettuale e narrativo, strumento di orientamento interpretativo, rimedio alle eccessive voglie di originalità, risorsa di proiezione e comunanza.
Davide Dal Sasso
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati