Futuro Antico. Intervista al collezionista Giuseppe Garrera
Dai musei come luoghi di pirateria alla sua ossessione per Pasolini, Giuseppe Garrera parla delle proprie passioni e si interroga sul futuro, che definisce “stupido”, proprio come il passato

Musicologo, storico dell’arte e collezionista, coordinatore scientifico del Master in Economia e Management dell’Arte e dei Beni Culturali della Business School del Sole 24 Ore di Roma, Giuseppe Garrera (Roma, 1962) parla di futuro e raccomanda a chi desideri intraprendere la sua strada di fare tesoro del “non saper vivere”.
Quali sono i tuoi riferimenti ispirazionali nell’arte?
Riferimento inevitabile è il British Museum come magnifico luogo di pirateria, di un popolo di pirati, di una fantasmagoria delinquenziale, e di cosa significhi mettere su una collezione con tutti i segni del massacro, dell’avidità, dello splendore, della ruberia e della nevrosi del possesso e dell’accumulo: direi che amo molto quei musei che conservano il segno dell’ingiustizia, dell’oltraggio e la pena di sogni e visioni idolatriche. Qui a Roma, più ancora di Villa Borghese (la ferocia collezionistica di Scipione Borghese è un modello irraggiungibile), il Museo delle Civiltà: con l’accumulo e lo splendore di opere e manufatti e beni preziosi rubati e dove anche la disciplina e la virtù dello studio tradiscono in realtà bramosie e insonnie per smalti, ceramiche, ori, suppellettili, avori, stoffe istoriate, statuette, idola, portafortuna.
Se poi potessi esercitare la pirateria, allora il riferimento sarebbe la pittura veneta e, al centro della pittura veneta, l’opera di Tiziano ‒ Le tre età dell’uomo a Edimburgo, La pietà dell’Accademia, La punizione di Marsia a Kroměříž sono stati per me università di studi e ogni volta imprese. Per farmi capire: mi piacerebbe essere sepolto, come un faraone, con accanto al mio corpo una di queste tele a custodire la notte ‒ e, al centro dell’opera di Tiziano, l’Assunta di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. Già la nominazione è una incoronazione. Si tratta di un addio, del più grande addio della storia dell’arte. In primo luogo è un addio a Venezia (parliamo di nuovo di un grande sogno frutto di bottini e arrafferie), che si allontana all’orizzonte e come nell’alto dei cieli, per ogni viaggiatore che la lascia; e poi allegoria di ogni addio (cioè il vivere, la vita, come una forma perenne di non perennità e di lontananza).

Tiziano, Assunta, Santa Maria dei Frari Venezia
Qual è il progetto che ti rappresenta di più. Puoi raccontarci la sua genesi?
La recente mostra ideata e allestita insieme a Cesare Pietroiusti e Clara Tosi Pamphili per il centenario di Pier Paolo Pasolini al Palazzo delle Esposizioni di Roma, per il tentativo di mostrare le “ragioni filologiche” come ragioni poetiche e di guerriglia. La mostra aveva centinaia e centinaia di materiali originali, fino allo spasimo, e un principio formale di Pasolini stesso: l’odio per la forma compiuta e la rinuncia allo stile. E dunque una filologia radicale contro la scuola, gli studi, le pubblicazioni per contestualizzare, inscatolare e ordinare e che sempre si rivelano sistemi correttivi e pratiche di contenimento per rendere innocui tutti gli autori. Come insegna Carmelo Bene, un poeta, uno scrittore, un artista, se sono tali, sono sempre dei mascalzoni e dei farabutti, pericolosi (in un cinegiornale del tempo, di irrisione nei confronti di Pasolini, si diceva: “Quello che non ci voleva… era Pasolini”).
Che importanza ha per te il Genius Loci all’interno del tuo lavoro?
Come collezionista e raccoglitore di idoli, i luoghi sono per me sempre santuari e regni dispersi (direi che tutto è regno disperso), e gran parte del tempo è impiegato a riconoscere in case, biblioteche, cantine, punti di scarico le tracce di culti e passioni: ad esempio il mercato di Porta Portese, e cioè il luogo dove le cose, riversate a terra da svuota cantine e rigattieri, raggiungono il punto di massima umiliazione, è pieno di reliquie (carte, libri, documenti) di devozioni da mettere in salvo. Ma più in generale intendo molta storia della pittura come ex-voto di ringraziamento per luci, albe, tramonti, alberi al vento, muri, prati, campi, paesi e cieli, perlustrazione della santità dei luoghi e dei loro nomi; topografia anche nelle aureole dei santi o nel blu del mantello della Vergine. I miei luoghi (ad esempio la periferia operaia di Torino è stata per me più importante dell’anima) configurano una biografia come scienza araldica, ornamento, blasone, stemma e ordine cavalleresco. Poi, nel caso specifico, io vivo a Roma e dunque al centro delle macerie di tutte le storie e con migliaia di statue e quadri per catalogare ogni luogo (alcuni angoli di Testaccio dove abito, in odore ed essenze, custodiscono addirittura la Calabria infelice dei miei avi), ma soprattutto, come detto, ci si aggira tra lutti ed eredi e tesori dispersi e racconti e genealogie da radunare e raccogliere.

Ketty La Rocca, volantino
PASSATO E FUTURO SECONDO GIUSEPPE GARRERA
Quanto è importante il passato per immaginare e costruire il futuro? Credi che il futuro possa avere un cuore antico?
Il futuro ha una caratteristica: è stupido, sempre; il nostro essere rivolti al passato in realtà è un desiderio abbastanza fallimentare di salvarsi dalla stupidità, ma ovviamente anche tutto il passato è stupido. Mio fratello, che ha spesso movenze da predicatore, in questi casi mi ricorda sempre che la verità è tutto ciò che abbiamo dimenticato: l’“antico” è questo oblio, e il futuro e la nostra attività d’arte e di collezione e catalogazione e operazione archeologica del presente, una lotta, non so quanto disperata, contro l’amnesia.
Quali consigli daresti a un giovane che voglia intraprendere la tua strada?
Di custodire una delle grandi virtù della giovinezza: il non saper vivere. Gli ricorderei che si va per musei, si legge, studia e ascolta musica perché non si sa come vivere. E poi di fare di tutto per salvarsi dalla miseria di sé stessi.

Pasolini nelle borgate. Dalla mostra P.P.P. Pasolini. Tutto è santo. Palazzo delle Esposizioni
In un’epoca definita della post verità, ha ancora importanza e forza il concetto di sacro?
Tutte le persone sono santi, diceva Pasolini, le cose tutte epifanie e addio. Non dimenticherei mai che noi godiamo del privilegio di morire, e, finché avremo questo privilegio, ogni atto e cosa nostra e sguardo sono e saranno santi. Ho appena sentito al telefono mio padre (che ha 89 anni): non ci siamo detti niente, ma ho sentito la sua voce e questo, come si suole dire, basta.
Come immagini il futuro? Sapresti darci tre idee che secondo te guideranno i prossimi anni?
Senza ombra di dubbio direi, prima: la gola, mangiare, pensare a mangiare bene, essere dei buongustai, come identificazione di vivere civile e vivacità, una civiltà di dediti alla gola e grati alla ristorazione. Lo aveva già predetto Giacomo Leopardi per il futuro di oggi, e mi sentirei di confermarlo anche per quello di domani: saper stare a tavola, andare al ristorantino speciale che sappiamo. Nell’ora della rivoluzione essere felicemente seduti a prendere l’aperitivo, e avere una gioventù di buongustai che parlano di ingiustizie.
La seconda: la vittoria definitiva dei ricchi. Non ci sarà più futuro per i poveri, nel senso anche di riguardo e stima o compassione (in realtà hanno già stufato da un pezzo, come diceva Flaiano). Terza idea portante, quello che aveva predetto, questa volta, Elsa Morante: la vita sarà costantemente usata. Usare la vita anziché viverla, il che è un oltraggio contro la vita. Io ovviamente parto già male con l’esempio dei miei genitori che hanno lavorato tutta la vita in fabbrica, per tutta la vita usati. Per tutto questo, nessun perdono.
Marco Bassan
 1 / 9
1 / 9
 2 / 9
2 / 9
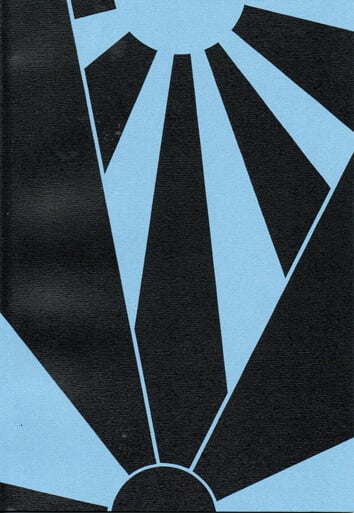 3 / 9
3 / 9
 4 / 9
4 / 9
 5 / 9
5 / 9
 6 / 9
6 / 9
 7 / 9
7 / 9
 8 / 9
8 / 9
 9 / 9
9 / 9
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati














