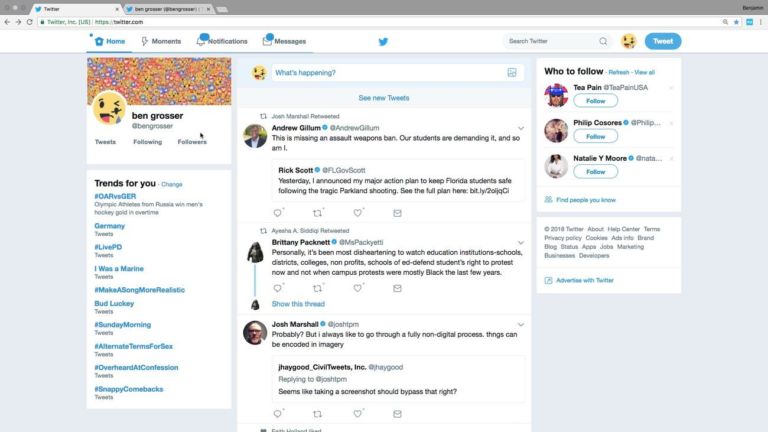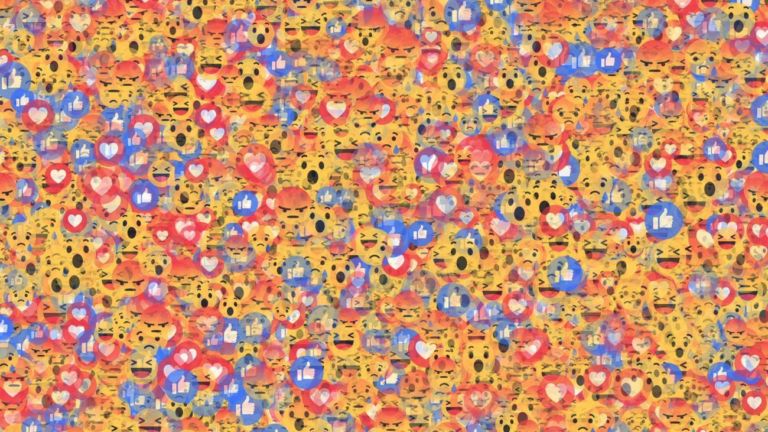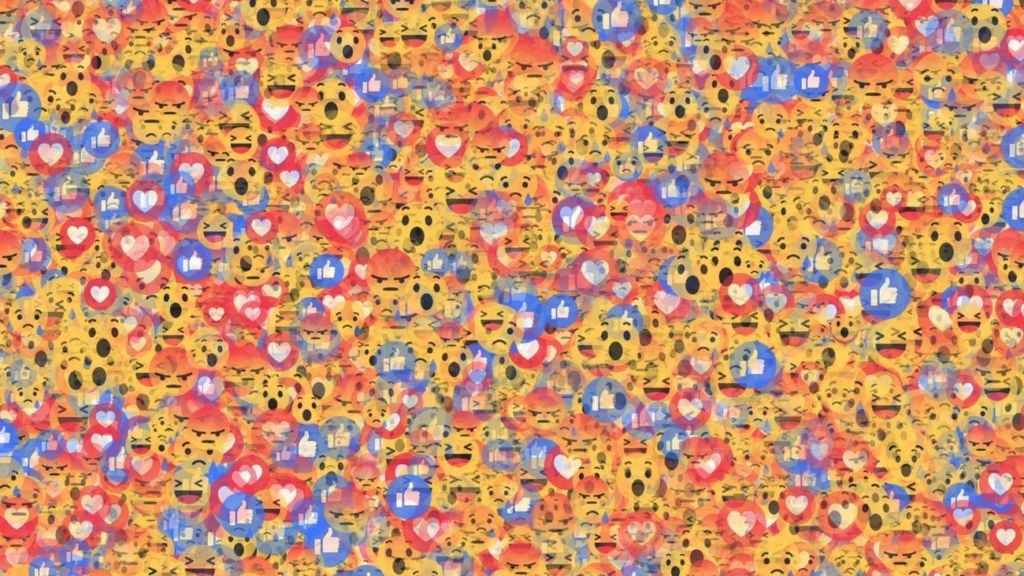
Benjamin Grosser è un artista americano interessato all’indagine sugli effetti culturali, politici e sociali del software. Ha realizzato numerosi progetti che mettono in discussione l’interfaccia dei social network più famosi privandoli dell’elemento più caratteristico: i numeri e le statistiche di gradimento. Insegna New Media alla School of Art + Design dell’Università dell’Illinois.
Alcuni tuoi progetti hanno anticipato di molti anni un cambiamento nel mondo delle piattaforme social che grandi corporation come Facebook e Twitter stanno adottando e discutendo in questi giorni. Mi riferisco alla rimozione dei numeri che riguardano i like e i retweet. Puoi raccontarci come hai avuto l’idea e come si è sviluppata?
Il Demetricator project è iniziato nel 2011, quando mi sono reso conto che stavo diventando ossessionato dai numeri del mio account Facebook. Dopo aver postato uno status, la cosa che volevo di più era sapere quanti like avevo ricevuto e quanto il post era stato commentato. Mi interessava di più che sapere a chi era piaciuto oppure cosa dicessero quei commenti. Una volta divenuto cosciente di questo, mi sono chiesto: perché? Perché mi importa così tanto dei numeri? Chi trae beneficio da questa ossessione e chi viene reso più vulnerabile da essa? Come artista sono interessato agli effetti culturali del software e volevo fare qualcosa che potesse aiutarmi a rispondere a questa domanda, così ho iniziato a scrivere del codice in grado di nascondere questi numeri. Nel 2012 ho rilasciato questo codice sotto forma di estensione per il browser e l’ho chiamato Facebook Demetricator. Usandolo, chiunque poteva provare a usare i social network senza numeri, in modo da sperimentare in prima persona come l’esperienza di tutti i giorni su queste piattaforme potesse cambiare. Nel 2017 ho realizzato un Demetricator anche per Twitter e più tardi per Instagram.
Da dove nasce questa ossessione per i numeri e per la loro crescita?
Guardando al di là di questa generale ossessione, ho anche realizzato che desideravo che questi numeri aumentassero costantemente. Più like era sempre meglio che meno. Volevo più amici, più condivisioni, più commenti. Questo mi ha portato a chiedermi se la presenza di queste misurazioni influenzasse i nostri sentimenti, e, in ultima analisi, le nostre azioni. Per esempio, vedere quanti like ha ricevuto il mio ultimo post cambia il modo in cui scriverò il prossimo? Sapere a quante persone è piaciuto il post di un amico influenza il fatto che piaccia o meno anche a me? Così ho cercato di approfondire attraverso le ricerche disponibili in quel momento e ho usato quello che leggevo ‒ insieme ai feedback che ricevevo dagli utenti del Demetricator ‒ per teorizzare quello che ho chiamato “desire for more” (desiderare di più). Questa teoria nasce dal nostro bisogno di essere stimati, un bisogno che si è sviluppato durante l’evoluzione. Per sopravvivere abbiamo bisogno di sentirci apprezzati, sia attraverso il rispetto degli altri che con la sicurezza in noi stessi. Si tratta di un bisogno che è stato molto utile per lo sviluppo della specie, ma in questo momento storico va a inserirsi in un contesto capitalista, in cui il valore è sempre quantificabile e la crescita è un requisito costante per il successo. Il risultato di questa intersezione – il nostro bisogno di essere apprezzati e l’ossessione capitalista per la crescita – ci ha portato a sviluppare questo desiderio così radicato per il “di più”. Inutile sottolineare come questa vulnerabilità si sia dimostrata utile per le grandi corporation che gestiscono i social network, per i governi e per molti altri soggetti.
Facebook Demetricator from benjamin grosser on Vimeo.
Le piattaforme social hanno reagito in qualche modo? Penso anche ad esempio a Go Rando, la tua estensione per il browser che randomizza le reazioni di Facebook. Hai ricevuto delle diffide?
Nei primi giorni in cui era online Facebook Demetricator, nell’ottobre del 2012, vedevo, attraverso le statistiche, che gli sviluppatori di Facebook stavano installando il software. Quindi ne erano a conoscenza sin dal principio. Ma non ho ricevuto nessuna comunicazione fino all’estate del 2016, quando Facebook avviò un’azione legale contro di me per rimuovere il Demetricator dal Google Chrome Web Store. Ci sono riusciti per qualche mese, poi ho avuto la fortuna di poter usufruire dell’assistenza legale della Electronic Frontier Foundation ‒ che era d’accordo con me sul fatto che il tentativo di reprimere una critica artistica da parte di una grande azienda come Facebook fosse un evento problematico per l’intera comunità di utenti ‒ e alla fine Google ha rimesso online l’estensione. Con il senno di poi penso che quell’azione legale fosse piuttosto buffa se consideriamo che ora stanno sperimentando la “demetrication” sulle loro stesse piattaforme!
Da Twitter invece?
Jack Dorsey, il CEO di Twitter, ha indirettamente riconosciuto il mio lavoro in una risposta a un tweet che conteneva un articolo su di me. Recentemente ha parlato molto dei pericoli di avere numeri visibili e Twitter ha sperimentato un po’ la cosa in una app beta nascondendo il conto dei like nei thread di discussione. Nessuno di questi esperimenti però ha raggiunto la loro piattaforma principale. Per quanto riguarda Go Rando e le altre manipolazioni relative a Facebook, non ho ricevuto più comunicazioni dall’azienda. Si tratta di progetti lanciati dopo le elezioni presidenziali americane del 2016 e dopo il referendum per la Brexit (e lo scandalo Cambridge Analytica), quindi forse sono stati molto occupati a gestire le proprie faccende legali per occuparsi di denunciare artisti indipendenti.
Comunque, per essere chiari, la mia intenzione è sempre quella di creare delle opere in grado di durare, che cambino l’esperienza che gli utenti fanno di un sito in modi nuovi e inaspettati, ma in un modo che eviti le classiche lettere di diffida che alcuni artisti sembrano così contenti di ricevere. Dalla mia prospettiva, ricevere una diffida è facile, mentre fare un lavoro in grado di sfidare le grandi corporation tecnologiche senza provocare una reazione legale diretta è molto più difficile. Mi concentro sulla seconda opzione.
La Net Art ha una lunga tradizione di indagine sul concetto di interfaccia, con progetti che ne mettono a nudo la struttura e le distorsioni. Pensi che il tuo lavoro si inserisca in questa tradizione?
Molti artisti e collettivi a partire dagli Anni Novanta hanno indagato le politiche dell’interfaccia e le sue strutture nascoste, tra cui (ma non solo!) I/O/D, Alex Galloway, Electronic Disturbance Theatre, Jodi, Eva e Franco Mattes, Mendi e Keith Obadike, Joana Moll, Julian Oliver. Sì, il mio lavoro è consapevole di queste ricerche e ne è stato ispirato.
Gli artisti hanno sempre giocato un ruolo importante nella critica e nella sovversione delle tecnologie. Pensi che questo ruolo sia valido e attivo anche oggi?
Il web, che negli Anni Novanta veniva visto come un’infrastruttura di comunicazione decentralizzata e democratizzante, è stato conquistato da poche piattaforme gestite da grandi corporation, progettate per tenere gli utenti all’interno di giardini recintati e centralizzati. Di conseguenza, è più importante che mai oggi il fatto che gli artisti sfidino ‒sia direttamente, che attraverso la critica esterna ‒ questi sistemi, sondando il loro funzionamento, spiegando cosa li rende possibili, chi ne trae beneficio, e chi invece diventa più vulnerabile. E anche se affrontare le aziende più grandi del mondo può sembrare una cosa spaventosa e difficile per un artista singolo, è molto più fattibile di quanto non sembri. Posso citare il mio stesso percorso come prova: nel 2012 molti giudicavano questa idea di nascondere i numeri sulle piattaforme social (che sono costruite tutte attorno a queste metriche), beh, abbastanza assurda. Mentre le persone che leggevano, correttamente, il mio lavoro come una critica all’interfaccia, capirono cosa stavo cercando di dire. E molti utenti tra quelli che hanno provato il software scoprirono di apprezzare i cambiamenti che rendeva possibile. Ma nessuno a quel tempo, me incluso, immaginava che dopo sette anni dal mio progetto, Facebook, Instagram e Twitter avrebbero sperimentato con lo stesso concetto.
ORDER OF MAGNITUDE from benjamin grosser on Vimeo.
L’arte quindi può ancora funzionare come una forza critica che aiuti la società a bilanciare le forze del mercato?
L’arte ‒ come disciplina che si concentra più sui problemi che sulle soluzioni, come pratica che lavora per mettere a nudo sistemi altrimenti nascosti ‒ si trova in una posizione unica per esaminare criticamente e per immaginare alternative alle piattaforme tecnologiche che sono oggi così ubique nella vita contemporanea. Gli artisti, a differenza delle grandi corporation, non devono rendere conto agli azionisti, non sono concentrati sul profitto e non sfruttano gli utenti. Questo li mette in una posizione radicalmente differente da cui poter considerare i sistemi che mettono in discussione.
Quali sono gli artisti e gli intellettuali che ti ispirano maggiormente al momento?
Per quanto riguarda teorici e studiosi, leggo regolarmente Mark Fisher, Wendy Chun, Geert Lovink, Matthew Fuller, Anne Helmond, Lucy Suchman, Søren Pold, Christan Ulrik Andersen, e Taina Bucher. Se parliamo di artisti, seguo il lavoro di Joana Moll, Julian Oliver, Lauren McCarthy, Ricardo Dominguez, Laura Poitras, Nicolas Maigret, Winnie Soon, Dries Depoorter e Julien Prévieux.
Su cosa stai lavorando?
Ho finito da poco un progetto enorme: un film che usa i video delle apparizioni in pubblico di Mark Zuckerberg tra il 2014 e il 2018 per raccontare l’ossessione capitalista delle grandi aziende tecnologiche negli ultimi quindici anni. Quindi ora mi sto un po’ riposando; guardo leggo e penso ai progetti futuri, ancora informi. Ci sono poi alcune cose in via di completamento, tra cui Autonomous Video Artist ‒ un sistema in grado di girare, montare e condividere la propria videoarte in maniera autonoma ‒ e una nuova estensione per il browser che rivela ai visitatori di un sito tutte le cose che lo sviluppatore voleva nascondergli.
Ho anche passato molto tempo a studiare i software dell’industria musicale, dalle digital audio workstations come Ableton alle piattaforme di distribuzione come Spotify, riflettendo su come il loro design influenzi la musica che ci piace, la musica che vogliamo e la musica che conosciamo. Infine, sogno sempre di mettere in cantiere nuove manipolazioni dei social media, quindi è sempre possibile che nascano altri lavori da quel filone di sperimentazione.
‒ Valentina Tanni
Versione integrale dell’articolo pubblicato su Artribune Magazine #52
Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati