Documenta dalla A alla Z
Cinque anni l’una dall’altra, circa tre per prepararla e allestirla. Documenta a Kassel è, insieme alla Biennale di Venezia, la rassegna periodica più importante nel mondo dell’arte contemporanea. Quest’anno la direzione è affidata a Carolyn Christov-Bakargiev, che ha impaginato una summa delle edizioni precedenti, senza sbavature e senza guizzi memorabili. Ve la raccontiamo in forma di lemmario.

A – arazzi
La tessitura è onnipresente a Documenta. Tappeti, arazzi e ricami ritmano come un ritornello tutta la mostra. Dalla mappa di Alighiero Boetti riproposta da Mario García Torres all’imponente arazzo ad emiciclo di Goshka Macuga, che collega idealmente Kassel con l’Afghanistan e ritrae molti dei protagonisti della mostra (curatori, artisti e collaboratori). E poi ci sono i bellissimi lavori della poco nota Hannah Ryggen, artista svedese nata alla fine dell’Ottocento. Tra gli Anni Trenta e Quaranta la Ryggen ha prodotto una serie di arazzi di tema antifascista e nazista: lo stile è crudo e naïf, il messaggio forte e drammatico. Una curiosità: alcuni di questi tappeti furono stesi dall’artista e da suo marito, il pittore Hans Ryggen, nel giardino della loro casa durante l’occupazione tedesca della Svezia.

Buio – William Kentridge
B – buio
Metafora del disorientamento che caratterizza il momento storico oppure scenografico espediente installativo? In entrambi i casi, risulta impossibile a Documenta non notare i numerosi spazi immersi nell’ombra o nel buio più pesto. Il caso più estremo è quello della performance di Tino Sehgal, hit indiscussa della mostra, durante la quale lo spettatore è costretto a lasciarsi andare in balìa dei performer in una stanza totalmente oscurata. Penombra anche per l’installazione di William Kentridge, che crea un’atmosfera in bilico tra il cinema d’essai e il luna park (stavolta l’artista sudafricano ha voluto vincere facile). E penombra per Kader Attia, autore di una delle installazioni più toccanti di tutta Documenta, sul tema della guerra e della deformazione. Sono buie, infine, anche le tante salette video, che diventano temporaneo rifugio per i visitatori più stanchi, pizzicati ad appisolarsi negli angoli.

Casette – Pedro Reyes
C – casette
Passeggiando per Karlsaue, il parco che fronteggia l’Orangerie, si possono incontrare oltre cinquanta opere, disseminate per viali, prati e boschetti. Alcune sono sculture, altre installazioni, c’è persino qualche performance. Ma la maggior parte sono… casette. Di tutti i colori e di tutte le dimensioni, vuote e piene, di legno e di ferro, abitate e disabitate. C’è il Sanitarium di Pedro Reyes, un piccolo ospedale che offre ai visitatori delle sessioni gratuite di terapia per riprendersi dalle “malattie cittadine”; c’è il rifugio di Chiara Fumai (una delle dodici presenze italiane a Documenta), una piccola costruzione bianca in cui si svolgono strane performance, da osservare sbirciando attraverso porte e finestre sbarrate. E poi ci sono le mini “gallerie”, venue improvvisate che hanno l’aria di funzionare da dépendance dello spazio espositivo, perdendo di vista il contesto naturale con cui dovrebbero interagire.

Discarica – Lara Favaretto
D – discarica
Un gigantesco ammasso di materiali di scarto, perlopiù metallici, un cimitero industriale, uno sfasciacarrozze disordinato e incongruo. È la proposta dell’italiana Lara Favaretto a Documenta. L’installazione, che occupa un grande spazio esterno nella stazione ferroviaria (Hauptbahnhof), è decisamente imponente ed è una di quelle opere su cui critici e visitatori si sono immediatamente divisi. C’è chi l’ha interpretata come una potente rappresentazione visiva di un momento storico tragico e violento e chi invece l’ha liquidata come una trovata scenografica e inerte, che non fornisce particolari emozioni. Qui e là, sparsi nel mucchio, ci sono dei parallelepipedi bianchi di cemento: sono lì a fare da segnaposto per alcune lamiere rimosse, esposte in un piccolo spazio chiuso adiacente.

Elicottero – Critical Art Ensemble
E – elicottero
Il rumore delle pale era costante nella zona dell’Orangerie. I visitatori, spiazzati, si domandavano se fosse un elicottero della polizia, impegnato in un’azione di controllo, oppure il lussuoso mezzo di trasporto di qualche vip in visita alla mostra. Invece l’elicottero che saliva e scendeva sui cieli di Kassel era un’opera d’arte firmata Critical Art Ensemble. A Public Misery Message: A Temporary Monument to Global Economic Inequality, questo il titolo, è un progetto che il collettivo americano aveva nel cassetto da molti anni, ma che non aveva realizzato finora per mancanza di fondi. Un trabattello e un elicottero che si alzano e si abbassano per rappresentare le diseguaglianze economiche negli States. Pagando una bella cifretta, o partecipando a una riffa, era persino possibile fare un giro in elicottero…

Futuro – Documenta off
F – futuro
Si tratta forse dell’unica pecca di questa mostra, altrimenti praticamente perfetta. Che sia voluto o meno – noi pensiamo di no – Documenta finisce per essere un’eccellente operazione di “riepilogo”. Parla del passato, con insistenza, ci fa scorrere davanti agli occhi pezzi di storia, più o meno recente, costruisce connessioni fra artisti diversi (e anche non artisti), epoche lontane, discipline varie. Ma quello che proprio non gli riesce di fare è guardare al futuro, immaginare scenari, azzardare previsioni. Non solo nei contenuti, ma anche e soprattutto nel linguaggio. Documenta è un perfetto esempio di “museo del contemporaneo”: varietà delle proposte, giusto balance geografico e allestimenti da manuale. Un progetto a rischio zero.

Grecia – la crisi
G – grecia
Documenta, come sovente accade, è in molte sue sfaccettature attenta all’altra parte del mondo: al sud, ai disagiati, ai poveri. Ai Paesi in via di sviluppo. E al tentativo di comprendere come questa “via di sviluppo” possa essere interpretata e come possa, oltretutto, integrarsi con chi “sviluppato”, per così dire, già lo è. Questioni di integrazione e reciproca convivenza. Poi succede che la crisi economica, virulenta come non mai, aggredisce l’Europa e che alcuni suoi membri assai simbolici come la Grecia rischiano di essere, loro stessi, riconfigurati come “Paesi in via di sviluppo” (testuali parole di fior di economisti). È solo a quel punto che capiamo quanto una mostra che richiede cinque anni di progettazione sia quanto mai difficile in momenti storici “rapidi” come questi.

Hotel – Mario García Torres
H – hotel
Alighiero Boetti ha costruito un immaginario complesso e affascinante attorno alla propria figura. Non soltanto attraverso le opere, ma anche con le sue scelte di vita (nel suo caso, i due aspetti erano indissolubilmente legati). Ne sa qualcosa Mario García Torres, che presenta a Documenta un progetto incentrato sulla figura dell’artista italiano, evocato con opere, lettere (buffe e toccanti quelle firmate da Harald Szeeman) e un lungo e appassionante video. Attraverso una sequenza di fotografie, commentate da una voce recitante, García Torres ci guida attraverso un vero e proprio processo investigativo. Alla ricerca di cosa? Del One Hotel, naturalmente, fondato da Boetti a Kabul negli Anni Settanta e poi scomparso dalla mappa.

Istanbul – la Biennale del 2011
I – istanbul
La biennale nella metropoli turca ha messo in crisi Carolyn Christov-Bakargiev? Ci sono critici e curatori pronti a giurare di sì. Parrebbe che, dopo aver visto la mostra a settembre 2011, la curatrice di Documenta si sia dovuta mettere lesta lesta a reimpaginare tutta la sua rassegna tedesca, visto che a Istanbul i curatori Jens Hoffmann e Adriano Pedrosa avevano indovinato esattamente ciò che lei voleva proporre a Kassel. Questo giustificherebbe anche il totale riserbo per quanto riguarda nomi, impostazione e anticipazioni: CCB non avrebbe rivelato nulla fino all’ultimo proprio perché impegnata a ripensare Documenta in base a quanto visto e non visto a Istanbul. Siamo nel campo delle illazioni, è evidente, ma del tutto verosimili…

Libri – Paul Chan
L – libri
Il libro è il simbolo per eccellenza della cultura umana. Nelle pagine di pergamene, manoscritti e volumi a stampa è conservata tutta la nostra storia: le narrazioni, le passioni, i conflitti, le speranze. E tutti i possibili punti di vista. In un momento storico in cui il libro come “contenitore” sta lasciando il posto a forme digitali e immateriali di trasferimento della conoscenza, l’oggetto-libro riconferma però la sua enorme potenza simbolica. E Documenta pullula letteralmente di volumi: ci sono quelli di Paul Chan, usati come supporti per la pittura; quelli intarsiati di Mark Dion al Museo di Scienze Naturali; quelli palestinesi fotografati di nascosto da Emily Jacir; quelli chiusi e muti di Haris Epaminonda e Daniel Gustav Cramer. E quelli bruciati e scolpiti di Michael Rakowitz.

Musica – Theaster Gates
M – musica
Le note risuonano un po’ ovunque a Kassel. Apprezzatissimo il tentativo di Carolyn Christov-Bakargiev di abbattere i confini fra le arti – e tra le discipline della conoscenza in genere – attraverso l’inserimento di progetti di danza, musica, teatro. La musica, in particolare, è molto presente. A cominciare dai jukebox di Susan Hiller che, piazzati in cinque diverse location, trasmettono una collezione di brani sul tema della libertà politica, della giustizia e della pace. Ma il progetto sonoro per eccellenza è quello di Theaster Gates. 22 Ballads for Huguenot House connette due luoghi lontani: Kassel e Chicago. Sono infatti due gli edifici in disuso protagonisti dell’opera: la tedesca Casa degli Ugonotti è stata ristrutturata e arredata con materiali di scarto provenienti dagli States e viceversa. Nelle stanze – camere da letto, cucine, piccoli studi di registrazione – abitano installazioni, video, incontri e tanta tanta musica.

Nuovi Vecchi – Julio González
N – nuovi vecchi
In una delle primissime sale del Fridericianum, nello stesso spazio, ci sono Ryan Gander e Julio González, rispettivamente classe 1976 e 1876. Un secolo tondo tondo di differenza anagrafica. E non è un caso unico, ma una tendenza dilagante. La curatrice olandese Saskia van der Kroef ha coniato, per descriverla, la definizione di “nuovi vecchi”. Parliamo della moda, ormai affermatissima in tutto il mondo, specie tra i curatori più giovani, di inserire nelle mostre artisti del recente passato, rigorosamente poco conosciuti o sottovalutati, con l’obiettivo di dimostrare l’attualità della loro ricerca. Una pratica che da un lato conduce a scoperte interessanti, ma dall’altro – non ce lo nascondiamo – sottende una consistente dose di narcisismo da parte del curatore hipster. Sfoggio di conoscenze? La nicchia, si sa, è il nuovo mainstream…

Oggetti – Michael Rakowitz
O – oggetti
Documenta fa continuamente riferimento alla storia, soprattutto nei suoi momenti più critici, cercando di indagare il collasso, la distruzione, il cambiamento forzato e radicale. In stretta connessione con questo tema c’è l’idea, profondamente evocativa, di pensare al mondo dal punto di vista degli oggetti. Cosa prova un oggetto? Ha un’anima? E cosa succede se l’oggetto in questione è un’opera d’arte? L’uomo inietta vita e significato nelle cose, anima i materiali, gli conferisce valori simbolici e gli affida narrazioni. Su una teca dell’installazione di Michael Rakowitz c’è una scritta, vergata a pennarello. Sono le parole del mullah Omar in occasione del bombardamento dei Buddha di Bamiyan: “Stiamo soltanto rompendo delle pietre”…

Primitivismi – Kader Attia
P – primitivismi
Nell’installazione al buio di Kader Attia, di cui parliamo nel lemma omonimo, sono decine gli artefatti esposti che l’artista ha raccolto nei suoi spostamenti fra Algeri, Kinshasa e Brazzaville. Una “ri-appropriazione culturale” operata dallo stesso Attia, ma prima ancora da quegli africani che hanno rifunzionalizzato gli oggetti occidentali, direzionandoli verso un decorativismo che nulla ha a che vedere con quel che solitamente osserviamo nei musei etnografici. Ma per Documenta s’incontrano vari altri esempi di arte “primitiv(ist)a”: dalle Principesse Bactriane scolpite circa 4mila anni fa in Asia Centrale alle opere di Julio González che provengono dall’edizione del 1959 di Documenta. D’altro canto, questa non doveva essere “la Documenta delle Documenta”?
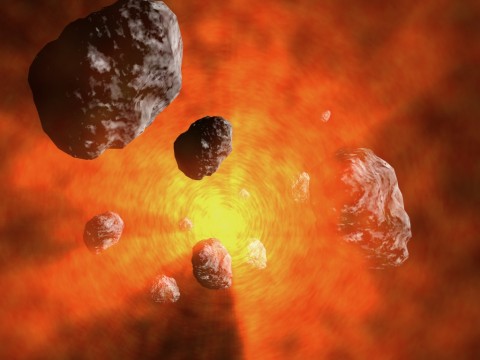
Quo Vadis – meteoriti
Q – quo vadis
La visita a Documenta, come quella alla Biennale di Venezia, fa nascere una necessaria riflessione sul ruolo delle grandi manifestazioni artistiche in questo momento storico. Rassegne di dimensioni ciclopiche, dai costi astronomici, che sottopongono il visitatore a maratone estenuanti in giro per città e campagne, mettendo a dura prova anche il più diligente e attento degli appassionati (quello che va in giro sempre con la mappetta alla mano, per intenderci). Ma serve davvero questa dimostrazione di forza muscolare? Nel testo introduttivo alla mostra, Carolyn Christov-Bakargiev racconta addirittura di un meteorite del peso di oltre 4 tonnellate che sarebbe dovuto arrivare a Kassel dall’Argentina (il progetto è poi stato annullato). La sensazione, insomma, è che un po’ di “decrescita” gioverebbe anche al nostro campo, soprattutto in fatto di eventi espositivi…

Rovine – un reperto del Museo della Preistoria libanese
R – rovine
Secondo l’interpretazione più benevola, il lavoro di Lara Favaretto (di cui parliamo alla voce discarica) simboleggia la rovina del nostro tempo e del nostro spazio, quello occidentale. Al di là delle chiavi di lettura più o meno solide, Documenta mostra parecchie altre rovine “indiscutibili” ed eloquenti. È il caso in particolare dei due oggetti provenienti dal Museo Nazionale Libanese, simboli tranchant dei disastri della guerra. In virtù della loro fusione, del loro diventare groviglio di materiali e storie, del loro essere dunque simboli a pieno ed etimologico titolo, finiscono nel “cervello” di Documenta al Fridericianum. Un po’ estetica delle rovine per come ce l’ha raccontata Marc Augé, un po’ estetizzazione dei danni provocati da un conflitto interno devastante.

Scienza – Anton Zeilinger
S – scienza
“Entri al Fridericianum e ti aspetti di vedere quel che usualmente è considerata arte. Invece”… Comincia così la presentazione in catalogo dell’opera di Alexander Tarakhovsky firmata da Adam Kleinman. E l’impressione – verificata sul campo – è che a Kassel la scienza serva giusto a dare quella spolverata di presunta apertura mentale che dovrebbe (?) impregnare la mente di ogni curatore, critico, visitatore. E allora si possono presentare progetti come quello dell’artista ex sovietico, che illustra in maniera piuttosto didascalica (e hirstiana nell’allestimento) alcuni concetti biomedici, dall’epigenetica al sequenziamento del Dna. Ma ce n’è pure per la fisica quantistica, con gli esperimenti condotti da Anton Zeilinger e portati di peso al museo. E da lui (o chi per lui) spiegati ai novelli discenti.

Teche – Gustav Metzger
T – teche
Documenta è una mostra storica. Sia quando espone veri e propri documenti, sia quando seleziona le installazioni, spesso ragionate come piccoli musei nel museo. Abbondano quindi le teche, di tutte le forme e dimensioni; armadietti e tavolini che custodiscono oggetti, lettere, reperti, residui. C’è addirittura un caso in cui le bacheche di vetro sono coperte da pesanti teli di stoffa che il visitatore deve sollevare per guardare le opere sottostanti (i bei disegni di Gustav Metzger). Ma la teca per eccellenza è quella voluta da Carolyn Christov-Bakargiev per la rotonda centrale del Fridericianum, sezione che lei stessa ha definito “il cervello di Documenta”. L’emiciclo è completamente avvolto da pareti di vetro, che lo separano dal resto della mostra come una camera iperbarica.

Urina – Takram Design Engineering
U – urina
Lo spazio dedicato a Takram Design Engineering è allocato in maniera un po’ infelice in uno spazio seminascosto della Documenta Halle. A dirigere artisticamente i metri quadri è la coppia costituita da Moon Kyung Won e Jeon Joonho, che ha raccolto una serie di progetti particolarmente interessanti che affrontano in maniera “catartica” la vita post-apocalittica che forse ci attende. In particolare si parla del consumo d’acqua: il nostro corpo ne è composto in una percentuale elevatissima e la dispersione è elevata. Perché dunque non riciclarla? Grazie all’Hydrolemic System si può: è “sufficiente” impiantare sul proprio corpo una serie di organi artificiali come i Nasal Cavity Inserts (che inibiscono la perdita d’acqua conseguente l’esalazione) o lo Urin Concentrator (che filtra l’urina e reimmette nel corpo l’acqua depurata). Per un corpo sostenibile.

Vento – Ryan Gander
V – vento
Documenta la si visita abitualmente partendo dal Fridericianum, sede storica della kermesse. E qui Carolyn Christov-Bakargiev ha impresso sin da subito un segno curatoriale forte. I due grandi saloni del pianterreno sono infatti monopolizzati quasi totalmente dall’opera impalpabile di Ryan Gander: una brezza che proviene dai bocchettoni dell’impianto di condizionamento, adeguatamente modificato. L’opera non si vede, i visitatori – anche quelli più smaliziati – ci mettono un po’ a capire quale sia esattamente il lavoro, la cui presenza è testimoniata soltanto dal cartellino con la didascalia. Capelli che si scompongono, gonne agitate, un po’ di sollievo dal caldo estivo che imperversa all’esterno, qualche piccolo accumulo di polvere che rotola negli angoli. L’opera non è nuovissima e di per sé non dice molto, ma funziona molto bene come incipit “arioso” e leggero per una rassegna che non è esagerato definire monumentale.

Zona – una scena dal film di Rodrigo Plá
Z – zona
C’è un film del 2007, il primo lungometraggio diretto dal messicano Rodrigo Plá, che si intitola proprio così: La zona. La zona è un quartiere, che a Città del Messico non esiste nel senso che non si chiama così, ma ce ne sono parecchi nelle megalopoli, soprattutto sudamericane. Sono enclave protette da muri, filo spinato, telecamere, sorveglianza. Dentro tutto dev’essere perfetto, sicuro, senza imprevisti, a prova di rivoluzione (all’esterno). E se dentro ci capita qualcuno, anche qualora si tratti di tredicenni rubagalline, non possono che fare una brutta fine, con la complicità fra chi sta dentro e chi permette che una zona possa esistere in quei termini. Ecco, Documenta 2012 è la zona dell’arte: tutto è perfetto, ma non accade nulla. Se il rimosso c’è, è già passato dallo psicoanalista.
Valentina Tanni
hanno collaborato Marco Enrico Giacomelli e Massimiliano Tonelli
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #8
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





