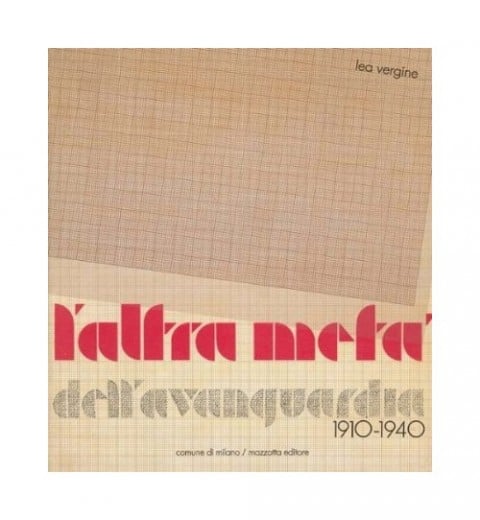Di Grande Madre non ce n’è una sola. Gioni a Milano
Ventinove sale regali con le opere di 139 artisti bastano appena per tratteggiare la fisionomia di una dea generatrice e divoratrice. “La Grande Madre” di Massimiliano Gioni più che una mostra è un museo ricco di suggestioni, eppure non memorabile, poiché apre molte parentesi senza tuttavia elaborare una nuova riflessione.

IL CONTEMPORANEO TORNA A PALAZZO REALE
Non ci sono dubbi che La Grande Madre, la mostra ideata dalla Fondazione Nicola Trussardi e curata da Massimiliano Gioni, è e sarà uno degli eventi artistici più centrali di questa Milano dell’Expo.
Da troppo tempo infatti in una sede istituzionale come Palazzo Reale latitava una vera e propria mostra di ampio respiro che investigasse un tema attraverso il lavoro di artisti dal Novecento a oggi. La mostra, promossa dal Comune di Milano, ha quindi il merito di restituire una centralità anche mediatica alla città sul fronte del contemporaneo, dopo che la scena è stata sostanzialmente monopolizzata dalla cattedrale eretta a luglio dalla Fondazione Prada.
La mostra, come è già stato ampiamente raccontato, traccia un percorso che lambisce tutte le possibili declinazioni del “materno”: visivamente, attraverso centinaia di opere di autori dalle avanguardie ai contemporanei, testualmente, tramite il lavoro di scrittrici e attiviste, e performativamente, grazie a esperienze evocate o presenti in mostra. È così che Massimiliano Gioni ancora una volta utilizza diligentemente il formato dell’enciclopedia della sua fortunata Biennale, e sempre più lo fa (almeno in apparenza) con piglio szeemanniano.
IL GRANDE TEMA: LA GRANDE MADRE
Come nei migliori romanzi, l’incipit è fondamentale per condensare in una parola o in un’immagine l’impianto narrativo dell’intero progetto. La Grande Madre apre inequivocabilmente con Abakan Red I (1970-73) della polacca Magdalena Abakanowicz, un’opera iconica che comprende nella sua forma tante possibili letture morfologiche del tema: una cellula uovo, un grembo, una vagina, un pianeta misterioso, un terreno fertile, la pozza di sangue di un sacrificio. E sono proprio questi echi formali che maggiormente risuonano e convincono nell’intera esposizione; li ritroviamo più avanti, in Brancusi, nelle opere-passepartout di Fontana e negli assemblaggi di Sarah Lucas.
Accanto all’opera della Abakanowicz troviamo un reperto inedito per i più della art-crowd (ma ovviamente non per chi conosce la storia del cinema): il primo film di Alice Guy-Blaché, la “prima” donna regista che scrisse e realizzò la sua Fatina dei Cavoli nel 1869, una pioniera senza dubbio, e la prima delle tante colleghe che punteggiano la grande esposizione.
La ponderosa prima sezione della mostra si focalizza maggiormente sulle personalità delle avanguardie, donne e uomini che hanno più o meno esplicitato il loro lavoro nelle arti tradizionali.
INIZIANO I PROBLEMI
Qui però il “discorso” di Gioni tende a ingarbugliarsi: da un lato abbiamo il côté esoterico-iniziatico di artisti come Olga Frobe-Kapteyn, dall’altro la rivelazione scientifica dell’inconscio attraverso Freud (con l’effetto memorabilia della foto insieme alla madre) e la ripercussione nel lavoro degli artisti espressionisti, simbolisti e surrealisti. A dominare queste prime e dense sale è spesso il malessere esistenziale e l’angoscia del materno, che transita dai Kubin, ai Munch, ai viventi David Hammons, toccando sostanzialmente tutti i vertici del Dada, del Futurismo e del Surrealismo. Qui il mito di Edipo viene evocato in maniera un po’ abborracciata: il focus sul Futurismo permette certo di rispolverare l’ambiguità di fondo di un movimento “maschilista” ma con in realtà (non poteva che essere così) una intensa presenza femminile.
Boccioni, il primo “mammone” delle avanguardie (ilare definizione provvista dal curatore durante la conferenza stampa), con i suoi ossessivi ritratti della madre svanisce come neve al sole davanti alla produzione di Valentine de Saint-Point, prima donna futurista “ufficiale” che con il suo Manifesto della Lussuria (1939) più che sulla maternità sembra anticipare la riappropriazione del corpo e della mente femminile in una rinnovata prospettiva. Non solo la Saint-Point ma altri nomi come Regina, Rosa Rosà, Benedetta, Emmy Hennings e Mina Loy emergono giustamente dal sostanziale oblio cui la storia le aveva rilegate. È con queste e altre personalità che si accompagna un senso profondo e mancato dell’opera d’arte, invero molto più interessante dell’artefatto patinato e pronto per il museo.
A questo proposito, la presenza della dadaista geniale Elsa von Freytag-Loringhoven, solleva seppure a bassa voce la questione sulla reale maternità della Fontana Duchampiana, che l’eccentrica baronessa (è ormai dimostrato, anche se omesso nei manuali di storia dell’arte) non solo idealmente concepì e del quale Duchamp sostanzialmente si impadronì. Ma siamo sicuri che tutto ciò riguardi il materno?
FEMMINILE O FEMMINISMO?
Alle opere della von Freytag-Loringhoven se ne accostano poi molte altre che più o meno direttamente ripropongono il ruolo della donna nelle arti del Novecento, le lotte, l’emancipazione e l’appropriazione dei diritti costantemente frustrati dalla presenza maschile. È qui che la mostra ancor più diventa una rapsodia del femminile, laddove femminile non coincide necessariamente con materno, e femminismo non si sposa con fertilità ma anzi, come si evince chiaramente in molti reperti dei movimenti femministi italiani, le protagoniste di quella stagione lottarono strenuamente per svincolare il genere dal destino forzato di “madri” o comunque di soggetti che occupano un ruolo secondario nella società.
Scorrendo le opere e i documenti di questa macro-sezione si può avere la sensazione di ripercorrere una storia passata e superata, dove icone sacre dell’arte come Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Diane Arbus o Cindy Sherman sembrano tranquillizzarci sul progresso e sull’equiparazione dei diritti delle donne nella nostra società, quando in realtà sappiamo che nemmeno nel mondo dell’arte le cose stanno così, basti pensare che le cifre raggiunte all’asta di un’opera di un’artista donna sono incomparabilmente più basse di quelle realizzate da un collega di sesso maschile.
Si ha quindi la sensazione che ancora una volta molte di queste opere rimarchino (in negativo) l’onnipresenza maschile, senza per altro considerare temi contemporanei come la fluidità del gender, ma ribadendo invece un narcisismo infantile di tanti, in un paese in cui l’immaginario collettivo è fortemente inflazionato dal materno. Spuntano così icone nostrane come Anna Magnani e Sophia Loren che hanno consacrato, insieme alla declinazione Pasoliniana di Medea-Callas, il culto e fardello della donna costretta ad incarnare una femminilità dolente ma indistruttibile.

Magdalena Abakan, Red I (1970-73) alla mostra Art and the Feminist Revolution al MOCA di Los Angeles, 2007
LA GRANDE FIGLIA DI ALTRE MOSTRE
Durante la conferenza stampa della mostra i curatori hanno giustamente celebrato Lea Vergine (presente in sala) e la sua rivoluzionaria mostra L’Altra Metà dell’Avanguardia che nel 1980, proprio a Palazzo Reale, metteva in luce il ruolo femminile della prima metà del Novecento. Certamente La Grande Madre non è una mera riproposizione di quella grande pagina della storia delle esposizioni italiane, ma non può evaderne il confronto.
Vi è purtuttavia un’altra importante mostra che rimane costantemente sottotraccia così come il suo ideatore Harald Szeemann, La Mamma che nonostante non fu mai realizzata sopravvive nel suo impianto concettuale, così come le altre mostre di spunto mitologico del grande curatore svizzero che riecheggiavano già nella Biennale di Gioni, raffreddate però da quella spinta innovatrice, anarchica, riformativa e fuori-formato che ne accompagnava la genesi, come si evince dalle parole di Szeemann nel ’78 descrivendo la mostra: “È una dea che per me ha quattro mammelle principali: la prima è l’anarchia, la seconda la riforma del corpo e dello spirito (dalla teosofia alla nuova danza), la terza la psicanalisi al servizio della rivoluzione (rivoluzione sessuale, ritorno al matriarcato venti anni prima di Reich), la quarta l’arte e la letteratura. […] far rinascere il culto dell’efebo, della donna, della grande madre, del vecchio saggio, degli elementi, degli astri”.
Raccogliere simili eredità curatoriali non è certo un demerito e può anzi mettere alla prova la contemporaneità di quelle intuizioni anticonformiste confrontandosi con lo stato reale del mondo dell’arte e del suo pubblico. Eppure, alla fine della visita la sensazione è di un’occasione mancata, conservatrice e circoscritta nella “comfort zone” borghese, probabilmente in parte dettata dalla cornice che ospita e promuove la gigantesca mostra. Va inoltre ricordato che molte delle opere esposte, soprattutto quelle correlate al tema del femminismo, furono già raggruppate come nell’importante WACK! Art and the Feminist Revolution del MOCA nel 2007 (andata poi al P.S.1) o nella più recente Woman. The Feminist Avant-Garde of the 1970s passata per Bruxelles e Amburgo; dove però in quelle sedi la metodologia adottata dai curatori permetteva di strutturare un discorso più focalizzato sul tema.
MI PARLI DI SUA MADRE
Al netto dei dubbi, si può accettare l’invito proposto da una mostra come La Grande Madre e lasciarsi abbandonare a quell’inconscio collettivo postulato da Jung e ribadito dal suo allievo Erich Neumann (a cui si deve la paternità del titolo della mostra), assorbendo i tanti capitoli dell’esposizione e lasciando all’irrazionale il compito di ricostruirne una logica individuale, emotiva e primordiale, come se l’intero impianto fosse una gigantesca fantasia prenatale che fa i conti sia con l’inconscio che con la biopolitica.
Se personalmente faccio questo esercizio, riaffiora la concretezza della materia primordiale uterina nelle opere di Ana Mendieta, l’affasciante visualizzazione dell’incubo ispirato all’universo femminile di Replace Me (2011) di Rosemarie Trockel, l’appropriazione dello strumento ironico/erotico dei collages di Ketty La Rocca, le poche ma deflagranti parole appuntante di Lee Lozano, l’esperienza offerta dalla performance di Roman Ondak del veder gattonare i bambini attratti dalle forme dalla gigantesca venere similpaleolitica di Jeff Koons, (svelando così, se ce ne fosse bisogno, il segreto del successo dell’artista americano). E ancora, la sublime e cronemberghiana scultura di Keith Edmier, Beverly Edmier, 1967 (1998), che da sola basterebbe a raccontare il materno come metafora di energia creatrice e determinatrice.
La Grande Madre è efficace maggiormente tanto più si sta al gioco proposto dal curatore, rivelando così l’aspetto accogliente, inclusivo e coccolone della grande Madre.
Riccardo Conti
Milano // fino al 15 novembre 2015
La Grande Madre
a cura di Massimiliano Gioni
Catalogo Skira
PALAZZO REALE
Piazza del Duomo 12
[email protected]
www.fondazionenicolatrussardi.com
MORE INFO:
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/46981/la-grande-madre/
 1 / 4
1 / 4
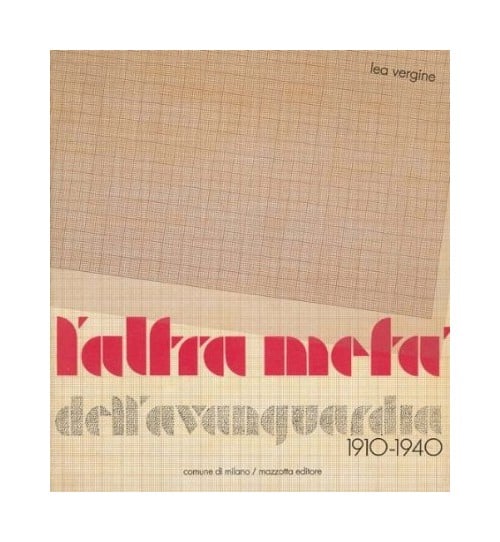 2 / 4
2 / 4
 3 / 4
3 / 4
 4 / 4
4 / 4
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati